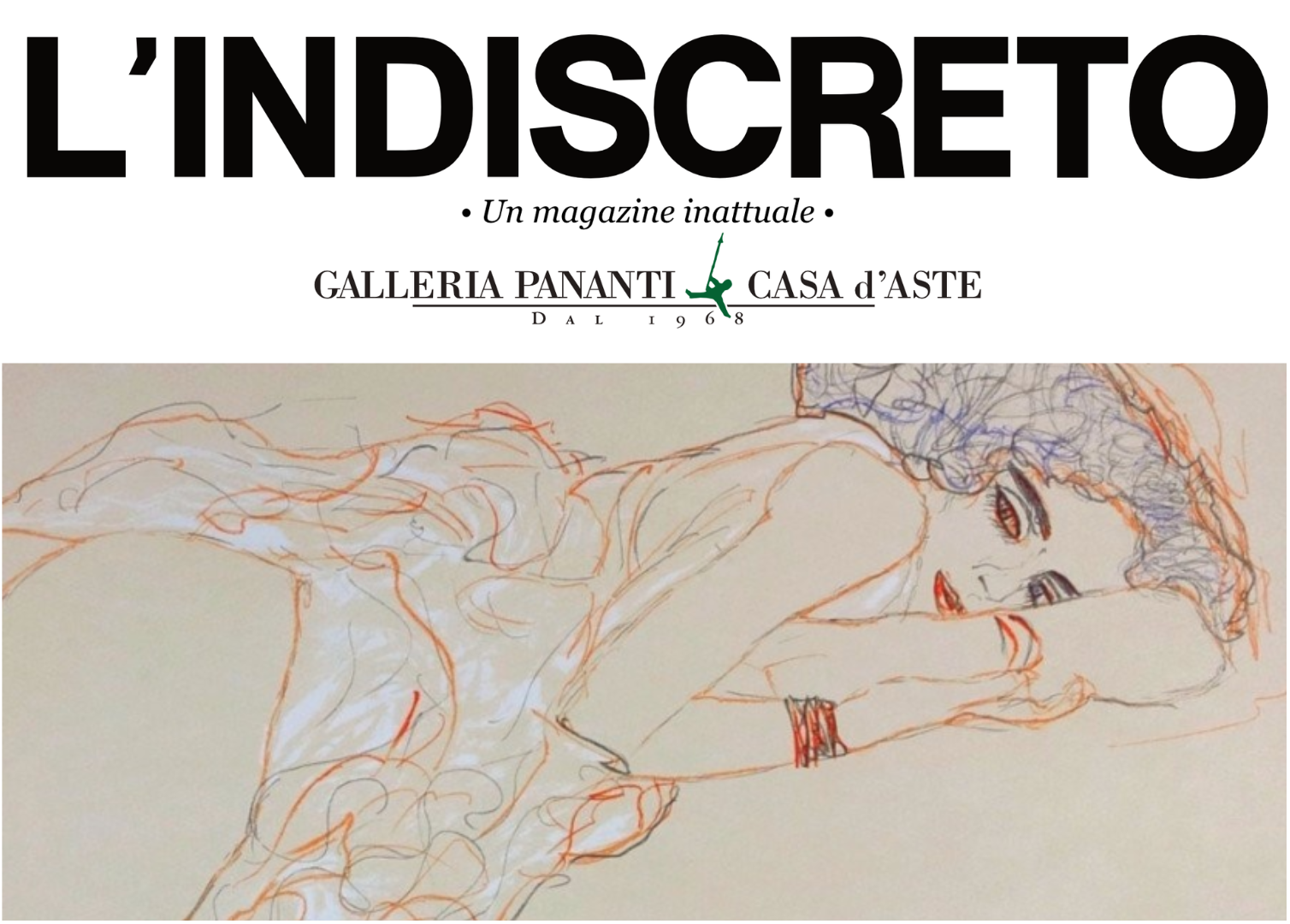La ricostruzione delle riviste culturali online in Italia – i loro protagonisti, le forme di sostenibilità, le strategie redazionali – è al centro del progetto “Per una storia delle riviste culturali online” a cura di Rivista Stanca. In un panorama spesso frammentario, in cui molte iniziative nascono e muoiono nel giro di pochi anni, L’Indiscreto rappresenta un’eccezione interessante: da oltre un decennio continua a pubblicare articoli di taglio culturale con rigore e libertà, sostenuta principalmente da una casa d’aste, la Pananti di Firenze. Un raro caso di mecenatismo contemporaneo applicato a una rivista digitale.
È anche per questo che, quando abbiamo deciso di avviare questa serie di interviste, volevamo parlare con Francesco D’Isa, direttore editoriale dell’Indiscreto. Filosofo di formazione, scrittore e artista, Francesco D’Isa è alla guida dell’Indiscreto da più di dieci anni, ma la rivista esisteva già negli anni Settanta, in una forma completamente diversa: allora era cartacea, con un’impronta satirica e una forte radice fiorentina. Oggi, nella sua versione digitale, ha trovato una nuova voce, più analitica e sperimentale, ma capace di mantenere un filo – anche affettivo – con la sua origine. D’Isa non arriva per caso alla direzione dell’Indiscreto: prima aveva fatto parte di Mostro, una delle esperienze più radicali e originali di editoria culturale online italiana, che abbiamo già raccontato in questa serie. È lì, in un contesto sperimentale e collettivo, che si è formato nel lavoro redazionale. Qualche anno dopo, arriva la proposta di rilanciare l’Indiscreto – un progetto con una storia importante alle spalle e una nuova direzione tutta da immaginare.
Partiamo dall’inizio: com’è nato il tuo coinvolgimento nell’Indiscreto e come si è trasformata l’idea iniziale in quello che è oggi? Avete cercato di mantenere un legame con la rivista degli anni ’70 oppure è stato subito chiaro che sarebbe stata una cosa nuova?
In realtà mi hanno contattato loro, tramite una conoscenza in comune: avevano proposto il progetto a una giornalista di Repubblica che conosceva il mio lavoro, e lei ha fatto il mio nome. Mi hanno chiamato, sono andato al colloquio, ho proposto la mia idea… e da lì è partito tutto. Mi hanno dato pochi soldi, ma tanta carta bianca. C’era una continuità di fondo, certo: era pur sempre una rivista culturale, i temi artistici erano importanti anche prima. Però dopo quarant’anni era anche inevitabile cambiare. La versione storica aveva un taglio più satirico, la nostra invece tratta i temi in modo approfondito. In fondo, le riviste sono diverse. Però loro sono soddisfatti: Piero Pananti, che è il fondatore del primo Indiscreto, è un fan della sua nuova versione.
Hai detto che rispetto al passato avete scelto un taglio più culturale e meno satirico, trovando una vostra direzione autonoma. Oggi, a distanza di dieci anni, come racconteresti il tipo di contenuti che caratterizzano l’Indiscreto? E guardando indietro, vedi un’evoluzione nei temi che avete scelto di approfondire?
La linea senz’altro si è affinata, ma non è stata decisa a tavolino. All’inizio ero l’unico a lavorarci, l’unica cosa che avevo deciso è di pagare chi lavorava scrivendo per l’Indiscreto. Questo ha funzionato perché era una delle prime riviste che pagava, soprattutto in quanto rivista online, ed era molto attraente. La linea editoriale è sempre stata legata ai miei gusti naturalmente, quindi filosofia, arte, letteratura e roba strana. Successivamente è entrato Enrico Pitzianti e questo ha influito nella linea editoriale, come influisce il contributo quotidiano di autori e autrici. Però la linea è rimasta più o meno la stessa, cioè trattare temi culturali nell’ambito di filosofia, arte, letteratura, e in parte anche nell’ambito scientifico. Spesso si parla anche di misticismo e religione, che è una cosa più rara da trovare perché è un ambito che interessa a me nello specifico. Abbiamo cercato di sviluppare un’apertura verso tematiche che altrove non vengono trattate o sono sottovalutate.
Un articolo che abbiamo pubblicato di recente secondo me è un po’ un manifesto della nostra linea: si tratta di un saggio sulla canzone Espresso macchiato di Tommy Cash. È un’analisi di un linguista fatta molto bene sul testo della canzone e poi paragonata a Gabry Ponte. Quindi argomenti e temi che magari sono meno palesemente intellettuali ma trattati con serietà scientifica. L’idea è questa, insomma: fare avanguardia culturale, correre il rischio di sperimentare, sempre con il massimo rigore possibile. Così pubblichiamo tutte le cose che altrove non troverebbero spazio.
L’idea di “avanguardia culturale” non sempre incontra il gusto di chi finanzia, eppure nel vostro caso è il contrario: Pananti, che aveva fondato la versione originale della rivista, oggi sostiene la nuova linea con entusiasmo. Oltre a essere il principale sponsor, la casa d’aste contribuisce anche in modo visivo: molte delle immagini che accompagnano i vostri articoli provengono direttamente dal loro catalogo. Com’è nato e come funziona oggi questo rapporto?
La casa d’aste è il principale finanziatore della rivista. Loro lo fanno per mecenatismo e poi si fa un po’ di pubblicità alla casa d’aste. Per questo la maggior parte delle copertine vengono dalle loro aste, perché così insieme all’articolo si diffonde anche l’immagine.
Altri finanziatori sono la casa editrice Olschki, sempre di Firenze, e la casa editrice Aboca, che è attiva da poco. Un’ulteriore fonte di supporto economico sono gli abbonati, una forma di finanziamento dal basso.
Da poco abbiamo introdotto gli abbonamenti perché gli sponsor hanno raggiunto il massimo del budget da dedicare alla rivista. Anche senza cercare un ulteriore sponsor, gli abbonamenti ci permettono di avere nuovo margine di crescita. Un altro aspetto positivo è che si tratta di un sostegno dal basso e ci fa piacere. L’ideale a cui puntare sarebbe di poter finanziare la rivista solo attraverso gli abbonamenti, tuttavia al momento costituiscono circa un quarto del sostenimento totale.
Quindi, nonostante il sostegno degli sponsor, la copertura economica non basta per far crescere davvero il progetto e il sostegno dei lettori è fondamentale. Ma concretamente, su cosa si concentrano oggi le spese principali dell’Indiscreto?
I costi principali sono costituiti dalla gestione del sito, dalla redazione – che è composta da me in quanto direttore, Enrico Pitzianti come caporedattore e da poco si è aggiunta Giulia Bocchio come redattrice – e dalle pubblicità sui social. In aggiunta vanno considerate piccole spese eventuali e poi i pagamenti degli autori.
Hai accennato al lavoro della redazione, che oggi siete in pochi a portare avanti. Com’è nato l’assetto attuale? E nel concreto, come vi suddividete i compiti tra direzione, redazione e collaboratori esterni?
Per quanto riguarda il lavoro principale, siamo in tre. Poi ognuno si è un po’ specializzato su certe cose, ma siamo abbastanza distribuiti tra editing, risposte alle mail, impaginazione del sito. Tutto il lavoro tecnico del sito per fortuna non è nostro, ma di un’azienda che ci segue. Però l’impaginazione degli articoli la dobbiamo fare noi, così come le grafiche, i post e la promozione sui social. Questo è quello che facciamo, diviso in varie proporzioni: io sono di sicuro la persona che ci lavora di più. Devo anche menzionare autori e autrici che ci aiutano con idee, proposte, pubblicità, anche loro contribuiscono, naturalmente in modo più libero. Edoardo Rialti ad esempio, che è uno dei primi autori che abbiamo avuto, non è mai stato stipendiato come redattore, non voleva prendersi un lavoro in più, anche se molto spesso ne fa le veci. Si tratta di un mix tra noi che abbiamo un piccolo pagamento e persone che ci aiutano anche gratuitamente.
Per tanto tempo sono stato io l’unico a lavorarci, poi Enrico mi ha mandato il curriculum – incredibile ma vero: è possibile trovare da lavorare anche inviando il curriculum a un perfetto sconosciuto. Giulia invece l’abbiamo chiamata, sapevamo del suo lavoro e gliel’ho proposto io. All’inizio, gli autori e le autrici li abbiamo reclutati più informalmente: gente che si leggeva in giro, persone che si incontravano e ci sembravano intelligenti – più spesso, persone che rientravano già nel nostro giro di conoscenze. La fase di scouting non è mai veramente finita, però la ricerca più intensa si è concentrata nei primi anni. Con il tempo, man mano che la rivista è cresciuta, autori e autrici hanno iniziato a proporsi spontaneamente. Oggi riceviamo tante proposte, e la maggior parte di quello che pubblichiamo arriva proprio da lì.
Una delle domande che ci poniamo spesso, anche nella nostra redazione, è come trovare un equilibrio tra il giusto compenso per chi lavora alla cultura e la libertà di fruire dei contenuti. Avere sponsor può aiutare, ma può anche porre dei limiti. Nel vostro caso com’è andata? Vi è mai capitato di dover scendere a compromessi?
È un equilibrio difficile da trovare. Indiscreto accetta di fare solo sponsorizzazioni di cose che ci piacciono, così non dobbiamo abbassare il livello qualitativo. Però questo limita molto la ricerca, gli sponsor, e le cifre. Quello che ci piace in genere non è ricco, purtroppo.
Soprattutto per le riviste culturali e progetti culturali è un inferno. È la cosa più difficile proprio in assoluto, perché si sa che la vendita delle riviste è problematica – in primo luogo perché sono richiesti dei fondi iniziali per la produzione. La pubblicità, d’altra parte, funziona solo su grandi numeri, quindi non ha nessun senso su riviste che non siano diffuse quanto Repubblica o il Post. Per quanto riguarda gli sponsor, il fatto è che vanno trovati. In questo ambito, una possibilità è il mecenatismo, come nel caso del Tascabile che è finanziata da Treccani, o Indiscreto con Pananti. Un altro modello è Lucy, che trova sponsor più danarosi e riesce quindi a ottenere una disponibilità maggiore. Mandare avanti una struttura editoriale di una certa dimensione richiede risorse economiche significative. Se da un lato la ricerca di finanziamenti è una difficoltà costante, dall’altro è una condizione imprescindibile: per fare una rivista, servono soldi.
Con Mostro facevamo autofinanziamento vendendo le copie per strada, e il ricavato bastava a malapena a coprire i costi di produzione. Questo modello, per quanto bello, non può durare a lungo: prima o poi le energie si esauriscono. Nel caso di progetti meno strutturati, come quello appena citato, il guadagno più grande non è economico ma formativo. È attraverso il lavoro che si impara. Io, ad esempio, ho imparato molto su grafica e illustrazione grazie a Mostro; Gregorio ha imparato a programmare. Insomma, un po’ tutti ci siamo formati lì. Però una volta che questa fase arriva a compimento, subentra la necessità di guadagnare. E a quel punto che si fa?
Se oggi arrivasse uno sponsor disposto a investire davvero nella rivista, con un budget consistente, cosa ne faresti? Cosa sogneresti di potenziare, introdurre o cambiare all’Indiscreto, se avessi finalmente la possibilità di farlo senza i soliti limiti economici?
Quello che cercherei di fare comunque sono piccoli passaggi. Cercherei di acquistare tutto quello che ci serve: principalmente autori ed autrici, oltre a materiale promozionale sia online che offline, per migliorare il sito e partecipare a eventi dal vivo. L’obiettivo sarebbe riuscire ad avere un progetto che ha un bacino di lettori sufficiente di modo che poi, da un punto di vista statistico, riesci a farlo sopravvivere con gli abbonamenti.
Una cosa che colpisce dell’Indiscreto è la varietà di voci e argomenti, anche rispetto ad altre riviste culturali che spesso tendono a seguire una linea più uniforme. Secondo te è anche questo che vi ha permesso di durare nel tempo, di costruire una forma di longevità?
La longevità si costruisce anche sulla varietà, sennò è finita. Se noi avessimo pubblicato sempre gli stessi temi, ad un certo punto avremmo esaurito le cose da dire.
Mi è capitato di parlare con una persona giovane, sui 25 anni, che mi ha detto che legge Indiscreto da quando era piccolo. Ai miei occhi i venticinquenni sono ancora “piccoli”, quindi la cosa mi ha colpito.
Non sono in molti, ma ci sono lettori che seguono davvero la rivista da tanto tempo. E quando qualcuno mi racconta che l’Indiscreto è diventato parte del proprio percorso intellettuale, penso che, in qualche misura, stiamo riuscendo in quello che ci siamo proposti. È qualcosa che succede con certe case editrici o con alcune riviste, e sentire che accade anche con la nostra mi dà un certo senso di continuità, quasi di responsabilità.
L’Indiscreto nel tempo ha subito un’evoluzione lenta, ma costante. Questa continuità, questa presenza così duratura, effettivamente dà modo di diventare, in un certo senso, un punto di riferimento.
Sono stato io a scegliere la strategia di non fare grossi cambiamenti repentini. Invece di fare un grande salto, molto costoso in termini di energie e ad alto rischio di implosione, abbiamo preferito mantenere piccoli avanzamenti costanti e questo ci ha mantenuti vivi. In più, abbiamo un numero sufficiente di lettori perché la rivista resti un investimento sensato per la casa d’aste. Evidentemente, per fortuna, la cosa funziona.
Puntare sulla comunità vi ha permesso di superare momenti difficili e costruire una presenza duratura. Ma una struttura così snella – con una redazione piccola e molto coinvolta – comporta anche dei rischi? Ci sono aspetti critici che vi portate dietro?
La redazione composta da un numero ristretto di persone ha degli aspetti positivi e negativi. Non abbiamo abbastanza soldi per avere i redattori nuovi. Poi ci appoggiamo ad alcuni esterni come Rialti, che ti dicevo prima, e Vanni Santoni. In realtà, Santoni segue le “classifiche di qualità”. La sua è stata un’idea che ha portato molto successo all’Indiscreto online. Insomma, una redazione di una decina di persone dipende meno dalle singole personalità che la compongono. Nel nostro caso invece se io o qualcuno si stacca da Indiscreto, Indiscreto non esiste più come prima. Quindi purtroppo è ancora troppo legata alle persone che ci lavorano. Questo è ciò che da un lato gli dà un carattere, ma è sempre un rischio.
Dopo tanti anni alla guida dell’Indiscreto, cosa senti che ti ripaga di più del lavoro fatto?
Ci concentriamo molto spesso su autori e autrici che sono giovani, proprio perché uno degli aspetti che secondo me è indispensabile per la rivista è far nascere e sviluppare nuove penne. Io sono molto contento di molti autori e autrici che hanno iniziato a scrivere da noi per la prima volta e ora invece scrivono libri, pubblicano. È successo molte volte, da autrici famose come Ilaria Gaspari che aveva già un libro alle spalle fino a Irene Todaro che ha scritto vari articoli per l’Indiscreto e che insieme a noi ha pubblicato un primo libro. Insomma, ci sono molte penne che poi hanno anche smesso di scrivere per noi, sono andate da persone che pagano meglio. Però è una cosa che a me rende molto felice, sviluppare talenti.
Questa è la cosa che più mi importa, intanto perché li conosco e mi arricchiscono sia culturalmente che personalmente, se ho l’opportunità di diventarci amico. E poi perché è quello che deve fare una rivista: fare posto ai talenti che nel canceroso mondo editoriale normale non troverebbero spazio.
Nel corso dell’intervista, Francesco D’Isa ha parlato più volte di comunità, di cura editoriale, di costanza. Ma forse è proprio in quest’ultima parte – quando racconta degli autori e delle autrici che hanno esordito sulle pagine dell’Indiscreto, e che oggi pubblicano libri, scrivono altrove, si fanno strada – che si intuisce il senso più profondo del suo lavoro.
L’Indiscreto non è solo una rivista longeva o un raro esempio di mecenatismo in Italia. È, prima di tutto, uno spazio che accoglie. Un luogo dove idee e voci ancora incerte trovano modo di esprimersi con rigore, di prendersi sul serio, di esistere anche prima di essere legittimate da altri canali.
In questo, la rivista si comporta un po’ come un passaggio: non trattiene, non chiude, ma apre. Non si impone, ma accompagna. Ed è forse questo il tratto più raro – e necessario – in un’epoca in cui le riviste sembrano nate per scomparire rapidamente, consumate dal tempo e dalla fatica.
È anche questo che cerchiamo di raccontare con il progetto “Per una storia delle riviste culturali online”: non solo testate più o meno riuscite, ma ecosistemi culturali in miniatura. Piccole scuole, luoghi di prova, forme di comunità. Spazi in cui si può ancora crescere, anche solo per un tratto di strada.