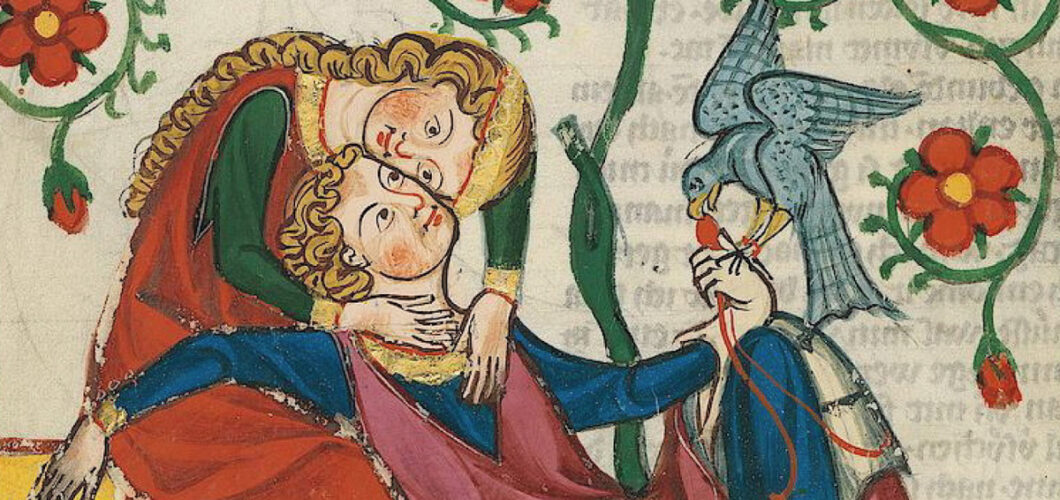«Per l’autore questi saggi sono – come la cattedra, il giornalismo o la politica – modi diversi di esercitare una stessa attività, di esprimere uno stesso sentimento. Non pretendo che tale attività sia riconosciuta come la più importante al mondo; mi considero giustificato, anche ai miei stessi occhi, avvertendo che è l’unica di cui sia capace. Il sentimento che mi muove è il più vivo che trovo nel mio cuore. Resuscitando il bel nome che usò Spinoza, lo chiamerei amor intellectualis. Si tratta, quindi, o lettore, di saggi di amore intellettuale».
Queste righe appaiono nella prima pagina di Meditazioni del Chisciotte, di José Ortega y Gasset. Come capita spesso quando un testo ha una soglia di ingresso particolarmente incisiva, è la parte di quel libro che mi è rimasta maggiormente impressa nella memoria, anche a distanza di anni dalla prima volta che la lessi. Mi è sempre piaciuto l’elegante understatement con cui si giustifica quello che si fa dichiarandolo l’unica cosa che si è capaci a fare (una scusa che, poi, spesso e volentieri ho fatto mia). E poi c’è quel sentimentalismo disinvolto ma non stucchevole con cui si chiama in causa l’amore. Quelli che seguono – viene subito premesso – sono «saggi d’amore», non sono mossi d’altro che da un sentimento amoroso. Questa è la reale giustificazione: occuparsi di cultura deve essere una espressione d’amore, altrimenti converrebbe occuparsi di qualcosa di più importante.
Meditazioni del Chisciotte è un libro strano. Pubblicato nel 1914, è il primo libro di Ortega y Gasset, filosofo spagnolo vissuto tra il 1883 e il 1955. A dispetto del titolo del Don Chisciotte e di Cervantes si parla relativamente poco: si compone di tre capitoli, i primi due (intitolati Lettore… e Meditazione preliminare) sono più che altro una lunga premessa metodologica, mentre il terzo (Meditazione prima) è l’abbozzo di una teoria del romanzo. Dopodiché il libro – rimasto incompiuto rispetto al progetto originario – si interrompe bruscamente, prima di essere entrato nel vivo di quello che avrebbe dovuto essere il suo argomento principale.
Le Meditaciones sono state lette e studiate soprattutto come testo che getta le basi del pensiero filosofico di Ortega y Gasset, specialmente di ciò che in seguito verrà battezzato “circostanzialismo” (il cui assunto fondamentale è riassunto nella citazione probabilmente più famosa del testo: «Io sono io e la mia circostanza, e se non la salvo non salvo neanche me stesso»). A me però interessano per un altro motivo, che vorrei qui approfondire: i primi due capitoli, quelli con la doppia premessa, mi sembra possano essere letti come un manifesto programmatico di un certo modo di intendere l’attività culturale. Vengono infatti messi in luce principi, motivazioni e metodi abbastanza duttili da poter essere applicati a buona parte di ciò che potremmo chiamare “atti culturali”. In particolare – ma qui mi rendo conto di star mettendo l’accento su ciò che più mi preme personalmente – alle forme del giornalismo culturale e del saggismo (che poi sono sostanzialmente la stessa cosa).
Torniamo ai primi paragrafi del libro, quando Ortega y Gasset presenta il suo progetto parlando di «saggi d’amore intellettuale». Immediatamente dopo avverte che tali saggi «mancano completamente di valore informativo». Dunque qual è il loro scopo? «In essi, partendo da un fatto – un uomo, un libro, un quadro, un paesaggio, un errore, un dolore – si cerca di condurlo per il cammino più breve alla pienezza del suo significato». Non si tratta quindi di passare informazioni, né di divulgare conoscenze già acquisite, ma di una ricerca. Partendo dal presupposto che «in ogni cosa c’è l’indicazione di una possibile pienezza», il ruolo del saggista è quello di impegnarsi attivamente per trovare/creare quella pienezza.
In questo senso si inizia a capire cosa intendeva Ortega y Gasset parlando di «amore intellettuale». Ad essere richiesta è una attenzione amorosa per l’oggetto di cui ci si sta occupando. L’oggetto non va solo studiato freddamente, va “trasfigurato”, “perfezionato”, “santificato” («Siano santificate le cose!»), “salvato”. È quello che, ad esempio, fa la buona critica, che all’interno di questo modello può essere descritta come una sotto-categoria specifica dell’attività culturale: nella critica l’oggetto che si mira di condurre alla sua potenziale pienezza è un’opera creativa. Il vero scopo della critica non è valutare un’opera, ma completarla o ampliarla: è «un fervido sforzo per potenziare l’opera scelta».
Ma siamo ancora troppo sul vago. Che significa “potenziare” o “condurre alla pienezza” qualcosa? Diciamo che ha a che fare con la profondità. Le cose si presentano a noi con la loro faccia, cioè con la loro superficie; il compito di chi vuole condurle alla pienezza è andare oltre la superficie, scoprire o far emergere la profondità che ci sta dietro. Ma dicendo così non facciamo altro che spostare la domanda: che cos’è la profondità? Ortega y Gasset dedica molte pagine a cercare di rispondere partendo da una metafora, anzi da un proverbio sibillino: «gli alberi non lasciano vedere il bosco».
Ora, il bosco è certamente qualcosa di profondo. Lo è perché non possiamo “vedere” il bosco in senso proprio. Quello che vediamo sono degli alberi, cioè la superficie del bosco. Potremmo addentrarci tra quegli alberi e così facendo scoprirne altri, ma continueremo, appunto, a vedere soltanto alberi, non il bosco, perché «il vero bosco è fatto dagli alberi che non vedo». Il bosco è qualcosa di «latente in quanto tale».
Eppure, anche senza vederlo mai, siamo coscienti dell’esistenza del bosco, perché sappiamo che dietro agli alberi che vediamo ce ne sono altri che non vediamo. E lo sappiamo perché possiamo intuirlo osservandoli, oppure immaginiamo che se ci avventurassimo tra di essi ne incontreremmo altri, o magari ce lo ricordiamo, perché effettivamente ci siamo già addentrati. In tutti e tre i casi – che si tratti di intuizione, immaginazione o memoria – riusciamo a cogliere il bosco attraverso una nostra operazione mentale che va oltre il semplice e passivo vedere. Possiamo dire che per essere consapevoli del bosco c’è bisogno della nostra collaborazione attiva.
Si può quindi intendere la profondità come il lato delle cose che è percepibile solo attraverso la nostra collaborazione. Se la superficie è il «mondo evidente», cioè la «parte di realtà che ci si offre senza altro sforzo che quello di aprire gli occhi e le orecchie», la profondità è un «oltremondo» che richiede «di compiere atti e sforzi maggiori». Ma, attenzione, «la misura di questi sforzi non toglie e non dà realtà a quel mondo». Insomma, la profondità è meno immediata, richiede di essere attivata, ma non per questo è meno vera della superficie, semplicemente «esige di più da noi».
Esistono diversi tipi di profondità, come del resto esistono diversi tipi di atti mentali che possiamo applicare alle cose-superfici che incontriamo. Facile intuire cosa sia una profondità puramente spaziale (“so che dietro a questi alberi ci sono altri alberi”) o una profondità temporale (“vedo una cosa e ricordo o immagino come in passato fosse diversa”). Ma – per riavvicinarsi al tema di questo articolo – che tipo di profondità possiamo cogliere e che tipo di sforzo facciamo quando compiamo un atto culturale?
Un po’ come la profondità del bosco è qualcosa che ha a che fare con il rapporto tra gli alberi che vedo e quelli che non vedo, così la “profondità culturale” che posso scoprire in un certo oggetto riguarda la relazione che esso ha con altre cose. Lo sforzo che compio per rivelare quella profondità consiste dunque nel trovare legami che mettano in comunicazione l’oggetto che ho preso in considerazione con cose che stanno al di là di esso. Tracciare connessioni: questo in sostanza è ogni atto culturale.
Più ampia e articolata sarà la rete di relazioni che riuscirò a tracciare, più sarò andato in profondità, più l’oggetto che sta al centro di quella rete sarà arricchito e, dunque, più mi sarò avvicinato alla pienezza delle sue potenzialità. Perché «si direbbe che c’è in ogni cosa una segreta potenzialità di essere molte altre cose, potenzialità che si libera e si spande quando un’altra o altre entrano in relazione con essa. Si direbbe che ogni cosa è fecondata dalle altre». Una cosa si determina davvero solo in relazione alle altre, dunque «se continuiamo a prestare attenzione a un oggetto, questo si andrà determinando sempre più, perché troveremo in esso più connessioni e riflessi delle cose circostanti». Ed eccoci arrivati a un’altra possibile definizione di profondità: «ciò che in qualcosa è riflesso, allusione alle altre cose».
In questo modo di intenderla, la cultura è il contrario della pura e semplice erudizione. Infatti, sebbene l’erudizione possa essere uno strumento utile per l’attività culturale, presa da sola essa consiste esclusivamente nell’accumulo di nozioni che valgono di per sé. L’atto culturale è invece l’opposto dell’accumulazione: è la creazione di reti di connessioni, tende alla sintesi, alla ricerca di significati che vanno oltre i singoli oggetti che prende in considerazione. Non si tratta soltanto di conoscere le cose, ma di estrarvi un senso.
E qui arriviamo al fine ultimo della cultura: «l’atto specificatamente culturale è l’atto creatore, quello in cui estraiamo il logos da qualcosa che era ancora insignificante». Si tratta di estrarre il logos o, se vogliamo, lo «spirito», o la profondità: sono tutti termini con cui si può indicare il “senso” di qualcosa, cioè le sue connessioni con tutte le altre: «Il “senso” di una cosa è la forma suprema della sua coesistenza con le altre, è la sua dimensione di profondità. No, non mi basta possedere la materialità di una cosa, ho bisogno di conoscerne il “senso”, cioè l’ombra mistica che il resto dell’universo spande su di essa».
Se poniamo queste basi all’attività culturale ne deriva come logica conseguenza che non esistono oggetti privilegiati da indagare, oggetti che, a priori, sono propri dell’ambito culturale e altri che non lo sono. Sotto qualunque superficie si può cercare la profondità, qualunque cosa può diventare materia di un atto culturale. Anche ciò che appare insignificante, soprattutto ciò che appare insignificante, dato che l’insignificante è per l’appunto ciò che da cui non si è ancora estratto il senso.
Gli oggetti culturali inequivocabilmente riconosciuti come tali, invece, sono cose su cui il processo di estrazione del significato è già stato compiuto. Sono «oggetti già purificati, che un tempo furono vita spontanea e immediata, e oggi, grazie al lavoro di riflessione sembrano liberi dallo spazio e dal tempo, dalla corruzione e dal capriccio». Vanno a creare il patrimonio di cultura acquisita, il quale, però, non va semplicemente conservato; al contrario ha valore solo fintanto che viene usato come strumento per nuove conquiste, come mezzo per allargare ciò che è culturalmente significativo. La cultura esiste solo fin tanto che continua ad essere una attività generatrice di senso in ciò che altrimenti ne sarebbe privo.
L’attività culturale è quindi un intervento per “salvare” le cose – che abbandonate a se stesse rimarrebbero povere, limitate, mute insignificanti – collegandole ad altre. Più sarà ampia la rete di collegamenti che riusciremo a tracciare, maggiore il senso e il valore che riusciremo ad estrarvi. Per questo l’impulso primo che muove qualunque atto culturale è uno sguardo sulle cose desideroso di senso. Il che è un altro modo di dire uno sguardo amoroso. E qui siamo tornati al punto di partenza: fare cultura è una forma di amore. L’indagine culturale più profonda sarà, idealmente, quella che riesce a collegare il proprio oggetto con ogni altra cosa, a creare una rete che da quell’oggetto si dirama a tutto il mondo, a renderlo il centro dell’universo. «Interroghiamoci sul senso delle cose o, che è lo stesso, facciamo di ognuna il centro virtuale del mondo», scrive Ortega y Gasset, che subito aggiunge: «Ma non è questo che fa l’amore? Dire di un oggetto che lo amiamo è dire che per noi è il centro dell’universo, luogo in cui si annodano tutti i fili la cui trama è la nostra vita, il nostro mondo, non sono espressioni equivalenti?».