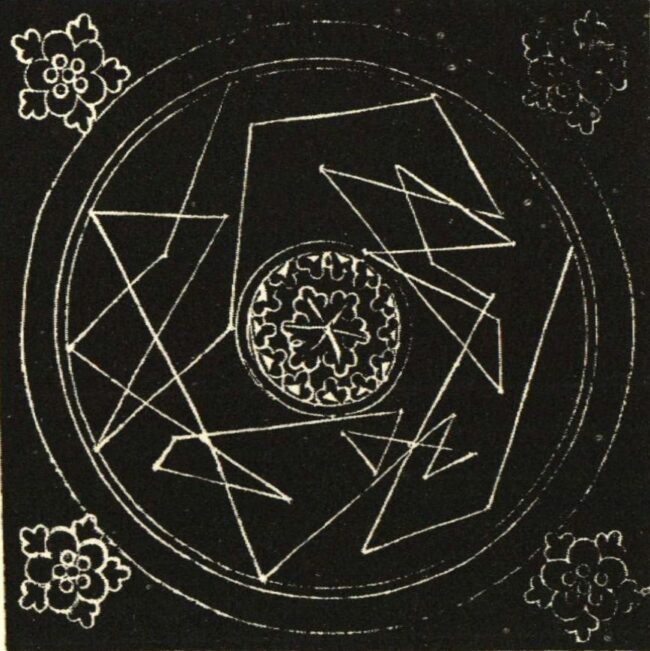A Beautiful Nothing di Enrico Terrinoni, uscito per la casa editrice Atlantide qualche mese fa, è un romanzo che si potrebbe definire un thriller letterario: una mise en abyme del giallo in una trama testuale del tutto letteraria.
Il romanzo alterna passato e presente, accordando al trascorrere del tempo la dinamica maestro/discente. Gli anni di snodo della vicenda dichiarati (1998 e 2016) riecheggiano un’ulteriore dimensione temporale, appartenente a un passato più remoto, che fa da filigrana e si specchia lungo l’arco di tutta la narrazione: è il 1906, l’anno in cui Joyce trascorse sette mesi a Roma, poco lontano dal luogo in cui venne imprigionato Giordano Bruno, la cui vicenda umana e letteraria si interseca a sua volta con quella joyciana. Il romanzo è una storia di ombre, che si proiettano nel passato, ma soprattutto nel futuro e di ‘Maestri alla quadra’, suddivisi in strane coppie che si incrociano fra di loro, Bruno e Joyce, l’anziano Professore e il giovane prof., e che dialogano attraverso il tempo e i testi. Perché forse, citando una frase del libro “la comunicazione avviene solo a distanza, come tra i libri, come tra particelle lontane anni luce che sanno dialogare quasi spettralmente”.
La mattina dell’intervista, il 14 giugno, Enrico Terrinoni ha tenuto una lezione a Pisa, presso il dottorato di filosofia, proprio sul rapporto fra Joyce e Bruno, dove ha messo in luce i risvolti visibili e invisibili del dialogo fra questi due intellettuali così lontani nel tempo e ha offerto uno scorcio del mistero di cui è soffusa l’attività letteraria dei grandi scrittori. Parliamo del suo romanzo e di Joyce, ma anche di letteratura, accademia, fisica quantistica e dell’importanza del precetto bruniano del “profondere nei sentimenti” quando si ha a che fare con letteratura e vita.
Nel tuo romanzo scrivi che “tutto ha origine nel reale e nella mente”: durante la lezione di stamattina hai parlato dell’equazione fra vita e letteratura, del rapporto costante di Joyce con il mondo esterno. Puoi parlarci di questo aspetto della scrittura joyciana?
Joyce è uno scrittore sui generis, parlare di lui richiede un discorso a parte perché è una sorta di singolarità, che sta ai margini della letteratura. Come spiega Frasca, traduttore di Beckett, Joyce fuoriesce dalla letteratura. Innanzitutto, perché i suoi libri non rientrano nel mercato letterario, come libri che devono essere venduti per guadagnare, e poi perché Joyce sfida il criterio di verosimiglianza, interessandosi al vero. Capisce che il romanzo, per come lo intendiamo comunemente, si occupa del visibile, di ciò che vediamo, delle azioni, delle storie, dei rapporti visibili, e tralascia la gran parte della nostra vita, che è l’invisibile e quindi il pensiero, il sogno, il silenzio e le interpretazioni. Vuole ottenere un tipo di struttura narrativa che catturi l’invisibile assieme al visibile e l’unica cosa che può fare è basarsi sulla vita, sua e dei propri familiari. Se uno cerca di rintracciare nell’opera di Joyce le invenzioni, si rende conto che ha preso varie cose da lettere, discorsi, rapporti reali. Un rapporto con la scrittura che possiamo definire anti-romanzesco, polemico nei confronti, appunto, del criterio di verosimiglianza del romanzo europeo tradizionale, perché è convinto che quella sia un’immagine circoscritta a una piccola parte della realtà. Si definiva addirittura uno scrittore non creativo: “io esco di casa e mi imbatto nelle cose che mi servono”. La sua scrittura si basa sull’esperienza, non su quello che insegnano ora le scuole di scrittura creativa, un lavoro a tavolino; vuole partire dal dato per modificarlo.
C’è un passo in A Beautiful Nothing in cui il giovane prof., a proposito di un testo che sta leggendo, dice: “qui si racchiude il senso del mondo”. Ma come hai sottolineato anche stamattina, i testi, in particolare quelli di Joyce, possono essere utilizzati per interpretare altri testi e sono soggetti a un continuo dialogo e ricircolo, anche nascosto.
Noi siamo abituati a concepire la letteratura come uno scrigno di cui cercare la chiave; uno pensa sempre che ci sia il modo di capire i libri. Quando reperisci la chiave per entrare in un libro di Joyce trovi il nulla o, meglio, un bellissimo niente, come lo ha definito Joyce, a Beautiful Nothing. Ma il nulla non è assenza, anzi è pienezza. Nella mentalità di uno come Joyce che crede nella coincidenza degli opposti il nulla è tutto, e anche in Bruno c’è questa dicotomia, che si riferisce ai “minimi e i massimi”: i massimi coincidono con i minimi. L’universo si espande, e dove si espande? Nell’infinito e quindi verso il nulla. Le teologie negative presuppongono che Dio sia il nulla, quindi tu non puoi mai arrivare all’estasi divina con la ragione, ma svuotandoti della ragione. Quindi il nulla che trovi nello scrigno è tutto, proprio perché una volta entrato hai acquisito degli strumenti per la tua vita. Tanti anni fa un mio professore irlandese, curatore dell’edizione Penguin, alla domanda “perché Joyce ha scritto l’Ulisse?” rispose “per farci sentire più a nostro agio nel mondo”. Se diventi come Bloom, un ebreo che non porge proprio l’altra guancia ma che non si vendica, e quindi se diventi in grado di non vendicarti per un tradimento, diventi migliore. Le opere di Joyce, come quelle di Bruno, sono opere umanistiche: servono a migliorare il mondo. Spesso noi andiamo alla ricerca di criteri estetici che sono invece narcisistici; i grandi scrittori non scrivono per farsi applaudire, ma per cambiare il mondo. Questa è la loro politica estetica.
A proposito della necessità di abbandonare il criterio razionale…
Abbandonare il razionalismo intellettualistico non significa abbandonarsi all’irrazionale, significa accogliere l’irrazionale. Ora che stiamo parlando, per esempio, io controllo i miei pensieri e tu i tuoi, e viviamo uno stato di reale controllabile, ma quando dormiamo non controlliamo; i sogni perturbanti, i sogni fastidiosi, non li controlliamo. E quindi il sogno non è reale? Se noi pensiamo che la nostra vita sia soltanto quella di tutti i giorni, quella razionale, dobbiamo pensare che l’altra non sia reale. Ma chi è che sogna? Non siamo forse noi? Questo significa allentare i freni della ragione, non significa abbandonarsi all’irrazionale come si potrebbe pensare, ma abbracciarlo, sapendo che probabilmente la maggior parte di quel che siamo è irrazionale. La parte intima, dei sentimenti, è irrazionale; noi non sappiamo perché piangiamo, perché ci innamoriamo. Razionalizzare le sensazioni significa restringerle. Questo discorso si può applicare anche alla letteratura. Tanta letteratura è scritta a tavolino. Insegnare gli incastri è quello che si fa ora nei corsi di scrittura, ma la vera letteratura è quello che smargina e che sta fuori, e che riesci a maneggiare fino a un certo punto perché si può solo intuire.
Da poco ho sentito una critica letteraria presentare un libro e dire che la letteratura a noi interessa perché riguarda la vita. Nel tuo romanzo ci sono tantissimi riferimenti a un altro tipo di vita, quella accademica. Ci sono i colleghi del giovane Prof., la pedanteria dell’accademia. Quando una collega chiede al giovane prof. di scrivere un articolo in una miscellanea di interventi, lui rifiuta, pensando dentro di sé che bisogna creare degli argini per non farsi sottrarre il tempo, e bisogna “dire no”, almeno ad alcune delle attività proposte. È un po’ come se alcuni aspetti e soprattutto alcuni impegni imposti dalla vita accademica fossero in realtà visti come una ‘dispersione’ dell’attività intellettuale, un differimento di un’indagine approfondita sulla letteratura, che richiede tempo e devozione (anche verso la sua sostanza ‘misterica’, che si percepisce pienamente nel tuo romanzo).
È un discorso molto complesso perché l’accademia italiana ed europea non va nella direzione dell’indurre a essere creativi, eretici, ma va verso la direzione del controllo, e allora i professori di oggi sono costretti a passare molto tempo a fare cose francamente inutili, piuttosto che cose utili. Da un lato queste cose sono obblighi burocratici, e dall’altro c’è la smania della pubblicazione, che fa sì che si venga giudicati più per la quantità che per la qualità, perché alcune riviste hanno il timbro di ‘fascia A’ e sono tutte cose che non hanno a che vedere con la creatività dell’intelletto. Poi c’è il discorso che in Italia per tanti anni, generazioni e generazioni di studiosi hanno pubblicato i propri libri con editori accademici a pagamento, pagandoli con i propri soldi della ricerca, e quindi non entrando mai nel circuito vero dell’intellettualità, scrivendo libri pubblicati in tot copie che poi rimanevano all’interno di questo circuito molto ristretto. Invece l’umanesimo parte da un presupposto molto diverso: i libri di Giordano Bruno non sono stati scritti per essere regalati al Professore della Sorbonne e ai Don di Oxford, ma erano libri che servivano a circolare e a cambiare le cose. Non potevano sottostare a queste logiche di pedanti; tant’è vero che Giordano Bruno in tanti libri si sofferma su questa necessità di non essere come chiama lui i pedanti, “grammatici”, ma di “profondere nei sentimenti”, ovvero entrare nel profondo delle opere con i sentimenti e non con la mera tecnica. La colpa ahimè non è degli intellettuali, la colpa è del sistema che non incoraggia alla creatività e all’essere innovativi, incoraggia invece all’essere predictable, prevedibili, a scrivere cose che non cambiano le carte in tavola. Io sono convinto dell’opposto, sono convinto innanzitutto che i libri sopravvivono alla loro vita perché hanno ancora qualcosa da dire e qualcosa che non è ancora stato detto e se hanno ancora qualcosa da dire è perché lo scontro è fra testa e testo, cioè le nuove teste leggeranno i vecchi testi. Questo discorso ha un risvolto anche in termini di pluridisciplinarità perché noi siamo abituati agli specialismi, ognuno sa il suo e poi tutti quanti ignorano quello che fanno gli altri, e invece la sapienza, la scienza, si basa sul maneggiare più territori, non uno solo. Ultimamente c’è un grandissimo fisico, Carlo Rovelli, che sta dicendo queste cose in maniera molto netta. Si occupa di fisica quantistica ma si addentra anche in questioni culturali. In uno degli ultimi libri che ha scritto, lui lo dice chiaro e tondo: “a noi i libri del passato non interessano per quello che dicevano allora, ci interessano per quello che dicono oggi”. È un’interpretazione quantistica, che si basa sull’interazione. Il fine della letteratura e del suo studio non è la conoscenza del passato, ma è la scommessa sul futuro. Rideclinando questo si capisce che la direzione verso cui va l’accademia è un cul-de-sac, un avvalorare quanto già scoperto. Si dice ai giovani “avvalorate le strade che abbiamo già previsto con le metodologie già sondate”, e invece no, il sapere nasce dall’opposto, nasce dal dubbio, dalla curiosità, dalla voglia di falsificare, di mettere in discussione i maestri, non di piegarsi a quello che dicevano le generazioni precedenti.
A questo proposito, nel tuo romanzo parli proprio di parole che lasciano la loro ombra nel futuro…
Sì, è proprio un concetto fisico. Noi usiamo il termine ombra pensando a qualcosa che ci precede, e invece è qualcosa che viene dopo. Quando proietti un fascio di luce su un oggetto l’ombra viene dopo e quindi l’ombra è il futuro, non è il passato. Anche questo concetto è fondamentale; quando si dice “l’ombra delle parole” si pensa sempre a quello che hanno accumulato nella storia e quindi si studia la storia della parola per capire cosa significasse prima. E cosa significa dopo? Se io prendo una parola oggi e ne cambio il significato? Questa è la cosa che fanno gli scrittori, Dante, Joyce, Blake, prendono le parole del passato e cambiano il loro senso. Dicono “non sono più interessato a quello che ha significato, che è scontato, ma a quello che può significare”, e questa è l’ombra, quel cono d’ombra che si proietta verso il futuro, che è materia di interpretazione probabilistica, più che di certezza deterministica come i paradigmi in vigore oggi vorrebbero.
Anche se tu confermi la possibilità di far convivere vita accademica e vita da scrittore, ma c’è una parte del romanzo in cui parli dell’amico magiaro del giovane Prof. che ha abbandonato la strada accademica per adempiere al suo sogno di diventare uno scrittore. Secondo te queste due attività sono compatibili?
Ti posso rispondere in molti modi. In passato c’era la coesistenza della dimensione di scrittura e vita accademica. Nell’ambito dell’anglistica c’era Pier Giorgio Manganelli, che era un professore universitario ma anche un grandissimo scrittore. La stessa cosa vale per il suo amico e sodale Gabriele Baldini, che è un grandissimo traduttore ma ha anche scritto dei libri di narrativa; Umberto Eco, Giulio Giorello, che ha scritto anche dei racconti del terrore. Era così, non c’era questo stacco, invece, oggi quello che sta avvenendo è che la letteratura segue anch’essa, quella pubblicata, quella delle case editrici, dei percorsi che non osano tantissimo. Basta guardare le classifiche. In questi giorni c’è proprio una polemica su questo: le classifiche dei libri venduti molto raramente includono libri ‘letterari’. Molto spesso includono libri di genere, quando va bene, altrimenti libri di altro genere, saggistica spicciola e perché? Perché il mondo dell’editoria si fa i calcoli. Puoi osare raramente, e rimangono fuori quelle che io chiamo letterature della complessità, quelle che scrivi non per incontrare un pubblico predefinito ma perché hai qualcosa da dire, e se hai qualcosa da dire uno dovrebbe aprirti le porte piuttosto che chiudertele. Quindi ora c’è questo problema, da un lato l’università diventa sempre più specialistica, e dall’altro c’è il mondo dell’editoria che frena rispetto alla vera creatività e interviene a gamba tesa sui libri. Sono rimaste poche le sacche di libertà. Penso che questo sia il discorso. Da un punto di vista pratico chiunque può scrivere un libro, poi invece, riuscire a incrociare un interesse sia del pubblico che dell’industria editoriale, questo è più difficile. Secondo me tutto bisognerebbe fare, tranne mettere paletti alla creatività, all’arte e alla libertà. L’arte è sinonimo di libertà, quando l’arte non è libera non è arte. In tutti i fenomeni storici, quando sappiamo che l’arte è commissionata dallo stato, quando si decidono di fare determinate mostre perché un artista è caro al presidente del consiglio o alla presidente del consiglio, stiamo riducendo l’importanza di un’artista a una finalità…quindi io credo che arte significhi libertà e l’artista deve essere libero di dire e di fare quello che ha in testa di fare.
Questa mattina hai parlato dell’ossessione numerologica di Joyce…a pagina 111 del tuo romanzo c’è una rivelazione, è un caso?
Non avendo impaginato io il libro non saprei dirti di quella, però ce ne sono altre. Ci sono quelle che Joyce chiamerebbe errori volontari. L’Ulisse è un libro pieno di errori, che portano a capire altre cose, sono spesso numeri, date. Io ne ho inseriti alcuni e anziché errori diventano modi di errare. E poi ci sono incroci di lettere, date di nascita. Magari qualcuno fra vent’anni prenderà in considerazione di scovarli…
Ti rimando una frase del tuo libro che mi ha profondamente colpito: “e se la comunicazione avvenisse solamente a distanza”?
Siamo abituati a pensare al dialogo fra i testi solo alla luce del concetto di intertestualità, ma c’è un concetto della fisica quantistica che spiega molto più semplicemente tutto questo, quello di entanglement. L’entanglement è l’affratellamento di particelle distanti che sono entrate in contatto e sono rimaste affratellate; quindi, quello che accade alla particella sulla terra comporterà un risvolto sull’altra che sta su Marte. Io credo che l’intertestualità potrebbe essere vista così. Non devo subire l’influenza di un autore solo se lo conosco con grande precisione, io posso aver letto anche soltanto una frase di questo autore e potrebbe avermi cambiato la vita. Il rapporto fra Joyce e Bruno funziona così. Noi sappiamo che Joyce aveva solo un libro di quelli di Bruno in biblioteca, però sappiamo che cita da tanti altri. Non sapremo mai quanto davvero avesse letto di Bruno, sappiamo però che, per qualche motivo, le particelle Joyce Bruno si sono incontrate e quello che succede a uno succede all’altro, rimangono affratellate. E io penso che questo accada anche nella vita, incontri una persona e ti cambia la vita, vedi una persona e ti cambia il modo di sentire, una frase detta da un professore alle medie ti può cambiare il destino. Questo significa “profondere nei sentimenti”, entrare non nell’irrazionale, ma dare per scontato che il razionale cattura pochissimo, è importante ma è sempre poco. È il 4% del cervello e dell’universo. Il resto è intuizione, guardarsi negli occhi, capirsi. Sono cose che non si possono razionalizzare.