In ogni manuale di teoria della letteratura ricorrono continuamente le espressioni “patto con il lettore”, “sospensione dell’incredulità”, “regole del gioco” per descrivere la relazione di consenso tra chi legge e la predisposizione tradita, giocosa, inconsueta del materiale narrativo. La natura della letteratura, in questo senso, equivale a quella del gioco. Scrivere è giocare e proporre quel gioco con le sue specifiche regole a chi, leggendo, ne accetta le condizioni e dà il consenso per essere trascinato dentro le sue fantasticherie.
L’editoria italiana dell’ultimo anno sta estrapolando in modo sempre più esplicito questo tratto intrinseco del fare letteratura. Se di per sé scrivere, senza bisogno di specificarlo, rappresenta un’esperienza giocosa di fantasia, contestazione del reale e “facciamo finta che”, in quest’ultimo anno sono proliferate esperienze editoriali che invece in modo assertivo si presentano come gioco prima ancora che come letteratura. Perché è diventata necessaria quest’inversione nella definizione? Come mai l’editoria sta puntando così tanto sul libro-gioco esplicito dimenticando che il libro-libro, per sua natura, è sempre e inevitabilmente un gioco a cui stare? Mi sembra tautologico specificare che un libro sia un gioco se la letteratura, da quando riunisce gli uomini intorno ai falò, è una creazione immaginifica che coinvolge in modo immersivo chi ne fa esperienza. In altre parole, la più antica delle finzioni.
A questo proposito è utile leggere Post-Digital Print, un saggio scritto nel 2012 da Alessandro Ludovico e ripubblicato nel 2025 dalla casa editrice Timeo. Lo studioso ricostruisce la parabola dell’editoria a partire dal momento in cui, già nel 1994, gli addetti ai lavori parlavano di scomparsa della carta causata dal digitale. L’e-book e la tecnologia sembravano innovazioni potenti capaci di spodestare ed eliminare per sempre la forma cartacea del libro tradizionale, e i loro punti di forza venivano descritti come novità mai viste prima nel mondo del libro. Invece, si legge nel libro, “qualcuno ha profetizzato la scomparsa dei libri, e ha sbagliato: prova ne è il fatto che il testo di Alessandro Ludovico che tenete tra le mani possiede ancora tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto i libri sin dalla loro invenzione”.
Il rapporto tra libro cartaceo ed editoria digitale ha già vissuto quello che ora sembra accadere tra narrativa e libro-game. Ovvero, si è creduto che la tecnologia possedesse novità inedite per i supporti dei testi, per poi scoprire – come ricostruisce Ludovico – che le apparenti invenzioni erano sempre state intrinseche nella forma cartacea del libro tradizionale. Il quale, proprio per questo, non ha vissuto nessuna rottura con l’era della tecnologia ma, anzi, si presenta in piena continuità e può resistere alla storia inventando addirittura rinnovate avanguardie artistiche con il longevo supporto cartaceo. Con l’aiuto di questo saggio potremmo guardare meglio all’interno del fenomeno libro-game per accorgerci che la giocosità, la sovversione e la partecipazione “immersiva” – parola chiave del nostro tempo – che ora sembrano essere portate in libreria solo dai prodotti editoriali partecipativi con quiz e indovinelli, sono da sempre tratti insiti nel fare letteratura e compresi in tutte le esperienze di narrazione e costruzione di una storia che trovano spazio nei libri da secoli.
Il libro-game non è una scoperta recente: nasce negli anni ‘30 quando escono Consider the consequences e Cain’s Jawbone, che Mondadori tradurrà in italiano solo nel 2022. Si tratta di una prima fase, che ha visto un’esplosione vera e propria nel mercato americano negli anni ‘80 e che in inglese è chiamata “Choose Your Own Adventure”, a specificare la conformazione a bivi di questi libri. Essi hanno varie possibilità di storie al proprio interno e una serie di finali alternativi: il lettore, compiendo le proprie scelte, è artefice della versione personale della storia. Quello che, per darci un riferimento più contemporaneo, la serie tv Black Mirror ha sperimentato con l’episodio lungo Bandersnatch nel 2018.
Storicamente abbiamo da una parte l’esperienza di lettura “sliding doors” dei libri “Choose Your Own Adventure”; dall’altra le ricerche autoriali di letteratura combinatoria o vincolata a specifiche regole compositive di Queneau e L’Oulipo. Entrambe queste esperienze non ripetono tautologicamente qualcosa che è già implicito nell’atto di creare letteratura, né presentano il gioco come un’introduzione inedita nella pratica dello scrivere. Essi configurano la struttura della materia letteraria in modo più aperto, spalancando le possibilità narrative e mostrando le possibili enfatizzazioni del tratto giocoso – mai negato – della letteratura stessa.
Quello che sta accadendo oggi, invece, mi sembra essere una negazione della natura giocosa della letteratura. Una ripetizione che suona ridondante a chi studia le teorie della letteratura ma che invece si vuole presentare a chi entra in libreria come un’innovazione assoluta nel mondo dei libri. Nell’editoria-industria il libro-game non ha tanto il ruolo di arricchire le potenzialità creative e fantasiose della letteratura, quanto quello di proporsi come prodotto più divertente, avvincente (e quindi meglio acquistabile) della letteratura semplice – per non dire noiosa. Da una parte questa dinamica può subordinare i libri di storie che non coinvolgono attivamente e materialmente il lettore – e forse è l’intento perseguito dall’industria; dall’altra però, come è successo alla carta nel corso della storia, può essere per i lettori critici e gli studiosi l’occasione per riaffermare il nevralgico punto di forza della narrazione stessa.
Ludovico, a proposito del supposto declino della carta, spiega infatti che “storicamente la natura statica e immutabile del medium stampato è stata la principale giustificazione per dichiararne l’obsolescenza”. E ora il superamento delle storie, nell’epoca dell’immersività, sembra essere imputato all’anacronismo di un’azione univoca, statica e poco attraente come la lettura. Post-Digital Print continua, però, dicendo che “paradossalmente è proprio questa pura immutabilità della carta che si sta man mano rivelando un suo punto di forza” e questo è l’effetto boomerang sulla narrazione che possiamo auspicarci dall’esplosione del fenomeno libro-game. Ma guardiamoli più da vicino.
Strani disegni (Einaudi, 2025) è un romanzo thriller da ricostruire come un puzzle tramite i disegni inquietanti che fungono da indizi per la trama giallo-horror. Il suo autore è Uketsu, una “celebrità sconosciuta e misteriosa in Giappone” ed è stato accompagnato all’uscita da una campagna promozionale fatta di meme, videogame, tiktok con i trend del momento, gif animate e ironia sarcastica da social network. Da controcanto a Uketsu, per Mondadori arriva Bartezzaghi, che ha nel cognome l’acume e l’ingegno dell’enigmistica, con Bozze non corrette. Un libro questa volta a metà tra la celebrazione del mestiere (svalutato) del correttore di bozze e, di nuovo, il gioco. Si può leggere come un romanzo che racconta la storia di un giallo, ma perché il suo enigma sia risolto è necessario trovare all’interno gli errori e scegliere quelli giusti per risolvere il caso. Un cubo di Rubik sotto forma di libro; perché il libro non ci basta più. Sellerio qualche settimana dopo promuove il Quaderno blu, una serie di giochi enigmistici a tema letterario che ricordano il Quaderno di compiti per le vacanze per adulti di Blackie di alcuni anni fa. Per Wundtz nel 2024 è uscito 1997. Il libro-game dei misteriosi anni Novanta, dove la scomparsa di un professore durante la notte di Halloween diventa un giallo da risolvere pagina dopo pagina. STC Edizioni accompagna l’uscita del romanzo Gli Ausiliari di Gabriele Esposito con un videogioco correlato e un premio in palio per i primi a completarlo. Verrà l’alba, starai bene di Gianluca Gotto, uscito per Mondadori, contiene al suo interno un quiz che enfatizza con il gioco il tema della ricerca spirituale al centro del libro. Se La mascella di Caino, uscito in Italia nel 2022, sembrava destinato a rimanere un unicum recuperato dalla tradizione degli anni Trenta, questo giro di pubblicazioni estive sembra far pensare alla nascita di una nuova e rinnovata tradizione di libri-gioco non più frequentata solo dalle case editrici specializzate nel settore.
Post-Digital Print fornisce delle coordinate per orientarsi in questo clima caldo: Ludovico, infatti, fa un discorso generico dicendo che “quando una tecnologia nuovissima e più potente sembra pronta a trasformare le regole stabilite di un dato sistema, allora l’intero sistema risponde gradualmente alla sfida”. Ad oggi non è dato sapere come il libro-libro tradizionale reagirà alla sfida del libro-game, però osservare l’andamento della sfida che il digitale ha posto alla carta può essere utile a comprenderne meglio gli sviluppi e anticiparne le conseguenze.
In questo rinnovamento proposto dalla febbre libro-game, infatti, sono problematici gli intenti e gli strumenti con cui l’editoria sembra voler supplire al bisogno di libri-gioco, e le motivazioni coincidono quasi specularmente con quelle che hanno portato a ipotizzare la scomparsa della carta nel secolo scorso. Umberto Eco per trasformare un libro in gioco inventava un doppio codice per duplicare la fruibilità de Il nome della rosa con cui cogliere tutti i rimandi nel libro, Calvino sperimentava le tecniche combinatorie per rendere il suo Se una notte d’inverno un viaggiatore un libro inspiegabile, Queneau si dava vincoli precisi per trasmettere il tratto enigmatico e a incastro delle parole, Consider the consequences giocava con le variabili combinatorie per potenziare l’esperienza narrativa, Perec si imponeva di scrivere un romanzo intero senza usare mai il suono “e” trasformando la scrittura in una challenge: quello che finora abbiamo chiamato libro-game o percepito come gioco letterario aveva come punto nevralgico il testo, le parole e la narrazione. Era un modo per far risaltare e mettere più in rilievo caratteristiche riconosciute alla letteratura, amate talmente tanto da volerle rendere ancora più evidenti anche a costo di calcare troppo la mano sulla centralità del testo. Infatti, quando Umberto Eco sentirà la critica definire “sperimentale” il double coding con cui ha reso ulteriore la costruzione de Il nome della rosa risponderà: “è stato forse inventato dalla modernità?”.
Enfatizzare una caratteristica della letteratura, magari più inconsueta rispetto a quelle evidenziate dai contemporanei, non è un modo per proporre un’esperienza alternativa a quella letteraria o per riempire le lacune che si rimproverano alla lettura con attrazioni più accattivanti. È un modo con cui Perec, Calvino, Queneau, Borges, Eco e tanti altri hanno confermato e dimostrato in modo ancora più palese del consueto che la letteratura, nel suo tradire, fare finta, immaginare e combinare, è da sempre un gioco (carnevalesco, direbbe Bachtin). Bisogna essere capaci di farlo risultare come tale: questa è la vera difficoltà di chi vuole rispettare quel senso giocoso della letteratura. Svilirla per sostituirla parzialmente con qualcosa che gioca con essa senza partire da essa è la via più facile per rendere il libro-game una versione 2.0 del libro-libro.
L’esigenza contemporanea, va detto, sembra essere quella di nascondere la noia della letteratura sotto l’aspetto invitante del gioco. Perché è qualcosa di strano, o perché così risalta come anomalia rispetto alla forma identica di tutti i libri da Gutemberg a oggi, e proprio per questo il fenomeno ha molto a che fare con la storia tracciata da Post-Digital Print. A guardarla bene, però, sembra una mossa più commerciale che ideologica, oppure una conseguenza di quello che Wu Ming 1 considera il problema a monte dell’editoria contemporanea: “quello delle vite logoranti, della fatica mentale, dei lavori di merda”, per cui forse gli scrittori contemporanei non riescono più a fornire antidoti e sollievi. Perché in effetti, un’altra dinamica assecondata dal fenomeno libro-game è quella della ricerca di gratificazione: se gli scrittori non sanno più offrirne e l’atto della lettura ha smesso di condurre a essa, il libro-game ricrea un legame con il lettore-giocatore facendolo sentire, alla fine del gioco, gratificato.
Confermano, poi, la ricerca di immersività e l’insoddisfazione per l’esperienza della lettura il ricorso degli editori a un podcast ufficiale (Vagabondi di E/O, SurRound di Sur o Vedere voci di Adelphi), oppure l’esperimento del romanzo a puntate diffuso su Substack da Paolo di Paolo per La Nave di Teseo: a prescindere dalla loro validità sono proposte che sembrano rispondere alla stessa dinamica di rinnovamento dell’esperienza letteraria che rende insufficiente il testo in sé. Un approccio assistenzialistico con cui si cerca di affiancare alla letteratura il più nuovo e inconsueto possibile perché sia allettante, rivalutabile, divertente. Perché possa farcela, e perché per farcela sappia reggere l’esigenza di spettacolarizzazione cui tutto concorre nella nostra cultura contemporanea. Una dinamica che si sintonizza con lo studio di Loredana Lipperini sull’idiosincrasia per la trama, sempre più rimarcata nell’editoria contemporanea e confermata ancora una volta dal tentativo di imporre la pratica del gioco su quella delle storie. Chiamando un libro “gioco” in effetti si annullano le categorie di trama, narrazione, ritmo ma si aumentano le possibilità di vendere qualcosa che, in sostanza, resta comunque sempre una storia.
Si conferma l’intuizione iniziale: non siamo più troppo capaci di rendere vitale un libro per cui cerchiamo fuori dalla letteratura stessa, fuori dalle storie, a prescindere dalle costruzioni con le parole, il gioco e il piacere che non consideriamo più un tratto proprio del testo. Marchingegni per non spegnere i riflettori sui prodotti dell’industria editoriale, ultime chance per provare a tenere in vita qualcosa che è più semplice considerare moribondo piuttosto che spendersi a far risorgere per ciò che potrebbe essere. È più corta la strada che estromette il gioco e l’invenzione dalla letteratura depositandola in altro, anziché quella che enfatizza dall’interno la vivacità che appartiene di per sé ad essa per renderla visibile anche da fuori. È il segno di un approccio che preferisce farsi assistenzialista anziché applicare le formule che fornirebbero una cura, cercare il gioco altrove invece di costruirlo con le parole.
Davanti a questo scenario la linea tracciata da Alessandro Ludovico in Post-Digital Print sembra fornire le indicazioni per un’inversione di rotta. Il gioco può smettere di essere l’assistente o il defibrillatore della letteratura se, per usare un termine di Ludovico, le dicotomie del libro – il digitale e il cartaceo prima, la storia e il gioco ora – tornassero a essere “sposate” fra loro. Dopo la ricostruzione di tutte le tecnologie alternative alla carta, dopo la scoperta di forme ibride tra carta e tecnologia e con l’approfondimento delle forme di editoria indipendenti che si sviluppano proprio dalla sopravvivenza del cartaceo e dal suo rinnovamento artistico e originale, infatti, Ludovico si concentra sull’inseparabilità delle due forme che nel tempo sono state raccontate come contraddittorie ed escludenti e che, invece, la storia ha rivelato più simili che mai e indispensabili l’una per l’altra. Se Post-Digital Print è l’inizio dello studio sul matrimonio tra “pixel, cellulosa ed elettricità”, il gioco e la letteratura hanno bisogno di un rinnovato studio che riporti al centro le similitudini tra due concetti talmente simili da essere, in questo momento, resi l’uno nemico dell’altro per semplicismo e grossolaneria.
Post-Digital Print paragona il processo di scalfimento del ruolo della carta a quello che ha investito il vinile nel mondo musicale. Si chiede “la carta stampata potrebbe diventare un giorno il vinile dell’editoria?”. I media digitali hanno immaginato di scalfire il broadcasting, ma l’hanno rafforzato; tre decenni di compact disc non sono riusciti a eliminare i vinili dal mercato musicale; un secolo di pronostici sulla morte della carta ha dato vita a infinite rigenerazioni del mezzo a stampa: tutto questo rende indispensabile studiare il fenomeno del libro-game, capirne le logiche, i bisogni e le promesse, proprio per permettere anche a questa nuova “tecnologia” di rivitalizzare la narrazione e le storie da cui promette di liberarci.
Se le avanguardie artistiche illustrate da Ludovico sono – le definisce Florian Cramer nella postfazione – “la preistoria del tentativo di risolvere le dicotomie”, così anche la narrazione deve trovare la sua avanguardia per reagire alla velocità dei nuovi modi di raccontare che i media, l’informazione digitale e la tecnologia hanno immesso nell’orizzonte dei lettori. Se, infatti, il web, gli e-book, il digitale sono state innovazioni tecnologiche che hanno riguardato il medium della carta; la narrazione semplificata, l’abbassamento della soglia dell’attenzione, la ricerca di immersività sono le nuove tecnologie di un dispositivo ancora più antico della carta, cioè l’arte del narrare. Come, allora, la storia di Ludovico dimostra la possibilità di far nascere dall’incontro-scontro tra tradizione e modernità una terza via che lui chiama “post-digitale”, così il libro-game è un primo segnale che anche per la narrazione devono esserci scontri fruttuosi di una narrativa post-digitale che non condanni, invece, alla sua già teorizzata scomparsa.

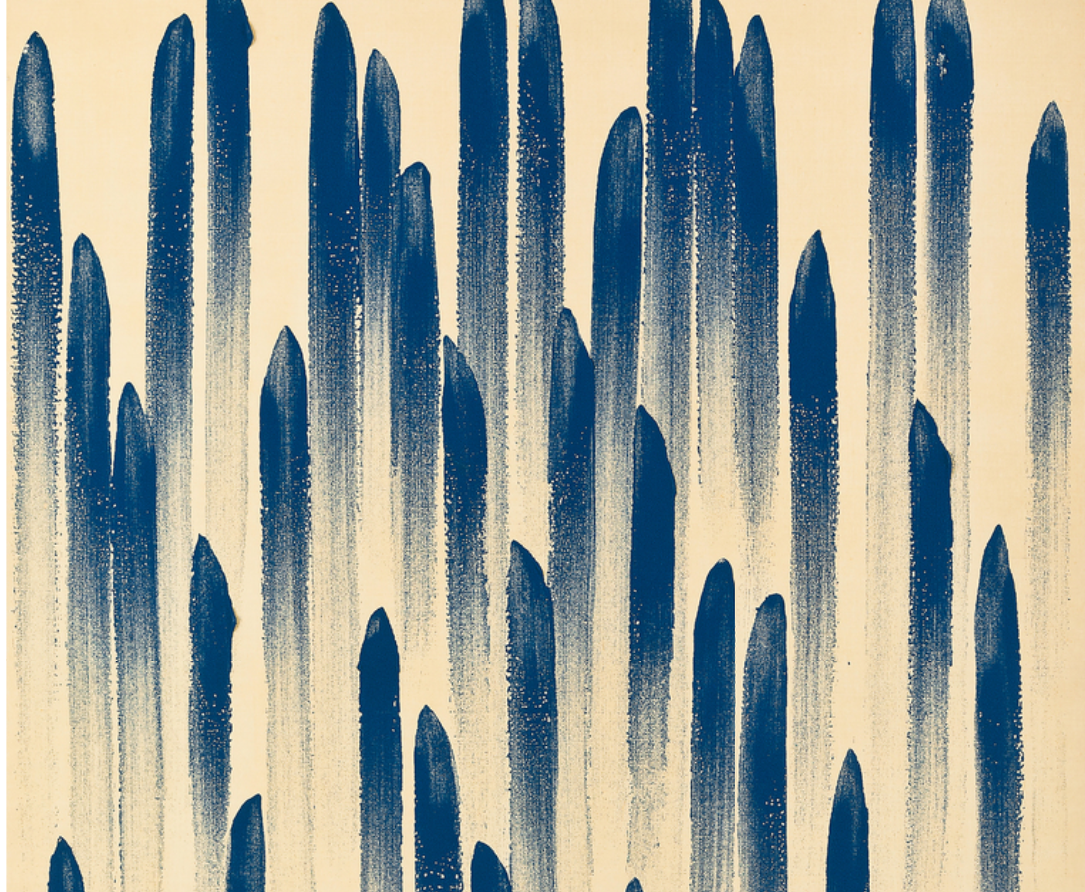
Lascia un commento