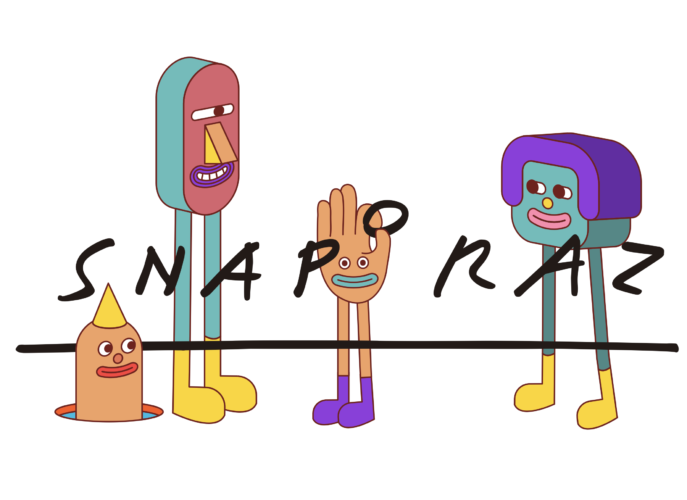La fine del 2022 e l’inizio del 2023 sono stati il periodo di fondazione di due riviste molto diverse tra loro. Uscite quasi in contemporanea, Snaporaz e Lucy sembrano avere target, obiettivi e idee molto diverse su cosa sia una rivista culturale oggi. Lucy è multimediale, ha una forte vocazione alla visibilità sui social, fonda i propri profitti sulla comunicazione digitale, è collegata alla casa editrice add. Snaporaz ha un’impostazione molto più tradizionale, pubblica pezzi critici brevi e qualche longform, si fonda visivamente soltanto sul rapporto dialettico tra testo e immagine, di recente ha avviato una collaborazione con il Secolo XIX per la pubblicazione mensile di un inserto culturale. Di Snaporaz abbiamo parlato con il suo direttore editoriale, Filippo D’Angelo.
Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 nascono quasi contemporaneamente Snaporaz e Lucy. Noi della redazione, che in quel momento eravamo studenti e studentesse della scuola del Tascabile, abbiamo immediatamente avuto la percezione che fossero nate due riviste molto riconoscibili, nuove e a loro modo “importanti”. Allo stesso tempo riconoscevamo subito le grandi differenze tra i due progetti. Come ti spieghi la loro nascita quasi contemporanea? A quali esigenze rispondeva Snaporaz quando è nata?
Snaporaz è nata in modo del tutto indipendente da Lucy. Sono venuto a sapere vagamente del progetto di Lucy solo qualche mese prima del lancio online di Snaporaz. Avevo invece parlato del progetto di Snaporaz a Nicola Lagioia, direttore di Lucy, nel maggio del 2021, durante una cena a Roma. Poi lo avevo via via aggiornato. Probabilmente Nicola stava già pensando per conto suo a un progetto di rivista digitale. In ogni caso non me ne parlò. Venni a conoscenza del progetto di Lucy molto più tardi tramite un amico comune.
Comunque sia, ho iniziato a ideare Snaporaz insieme a Gianluigi Simonetti nell’estate del 2019. Lui era venuto a Genova a presentare con me il suo saggio La letteratura circostante e da lì abbiamo cominciato a riflettere su alcune questioni che sono all’origine di Snaporaz. Gianluigi aveva concluso da qualche tempo l’esperienza di Le parole e le cose, gli accennai alla possibilità di fare una nuova rivista digitale su abbonamento, che pagasse i collaboratori e fosse sostenibile dal punto di vista economico. Avevo in mente una rivista francese che si chiama AOC, mi sembrava che in Italia non ci fosse nulla di simile. Nel 2020, durante la pandemia, abbiamo cominciato a ragionare seriamente al progetto. In seguito abbiamo coinvolto Patrizio Marini per l’impostazione grafica del sito e, dopo due anni di lavoro preparatorio insieme a lui, nel dicembre del 2022 la rivista era online.
Ho letto l’editoriale della vostra serie sulla storia delle riviste di Franco Cimei e, nonostante sia un ottimo pezzo, attribuisce a Snaporaz un legame genetico con Instagram che vorrei smentire in modo assoluto: nella concezione di Snaporaz la dimensione dei social non ha avuto nessuna importanza. Fino al dicembre 2022 io, che ero del tutto alieno ai social, non sapevo nemmeno cosa fosse una storia (e sino a poco tempo prima credevo ingenuamente che fosse possibile creare una rivista online senza usare i social). Di fatto, non abbiamo mai tenuto conto dell’algoritmo, siamo stati anche più volte bannati perché nei titoli c’erano parole o immagini che non andavano bene (una volta addirittura per l’aggettivo “armato” nella locuzione “cemento armato”).
Insomma, Snaporaz nasce come una rivista incentrata prettamente sui contenuti testuali e iconografici del sito (questi ultimi, molto curati, non sono a corredo “decorativo” dei testi ma in dialogo con essi; per la rivista è un lavoro e dunque un costo aggiuntivo, ma ci è sembrato che ne valesse la pena). Al cuore di questo progetto c’era e c’è la volontà di avere una dimensione critica riconoscibile e rigorosa: volevamo che fosse una rivista che facesse anche stroncature, che non facesse promozione culturale e editoriale, che non facesse recensioni o anticipazioni dei libri dei collaboratori. In un contesto in cui la “critica” degli inserti culturali è sempre più legata alla promozione e all’autopromozione degli autori ci sembrava un’operazione indispensabile, che potesse incontrare le esigenze di certi lettori.

Di recente avete fatto il percorso inverso rispetto a quello di molte riviste che raccontiamo in questo progetto: Snaporaz è passata dall’online al cartaceo, come inserto culturale del Secolo XIX, un quotidiano regionale, in un periodo in cui i giornali di carta sono in crisi.
Sin dall’inizio pensavo che una rivista culturale digitale impostata in modo professionale potesse avere sbocchi sul cartaceo. L’occasione si è presentata quando Il Secolo XIX ha cambiato proprietà e direzione. Tramite un contatto ho potuto presentare al nuovo direttore, Michele Brambilla, un progetto d’inserto. Il direttore ha reagito con entusiasmo e in pochi mesi siamo andati in edicola, con un progetto editoriale e grafico (sempre Patrizio Marini, sempre sia lodato) di cui sono molto orgoglioso. E siamo molto soddisfatti della sperimentazione di questa dialettica tra digitale e cartaceo (parte dei contenuti dell’inserto vengono poi progressivamente pubblicati anche sul sito di Snaporaz). Certo, i giornali di carta sono in crisi, ma oggi si ha a che fare comunque con un’idea molto digitalizzata del cartaceo (attraverso i pdf dei giornali), la quale forse ha ancora qualcosa da dire. Lavorando sul cartaceo ci si rende conto che è una forma molto più esigente, elegante e intelligente rispetto al semplice online. Mi riferisco alla necessità di rispettare una certa misura dei pezzi, di curare in un certo modo la titolazione, di concepire il rapporto dei pezzi gli uni con gli altri nell’oggetto inserto. Il fatto che Il Secolo XIX abbia una posizione un po’ “periferica” rispetto ad altri quotidiani costituisce, paradossalmente, un grande vantaggio: ciò ci permette, grazie alla lungimiranza del direttore del giornale, di sperimentare un formato d’inserto più innovativo e raffinato, credo, di quanto non sarebbe possibile collaborando con un grande quotidiano nazionale.
La scelta di pubblicare contenuti quasi esclusivamente a pagamento sfida un pregiudizio degli utenti di contenuti culturali online, per cui tutto ciò che è in rete dovrebbe essere gratuito e accessibile. Vi siete confrontati con questa questione? Che risposte state avendo?
In Italia la resistenza ad abbonarsi su internet a contenuti culturali scritti è molto più forte che in altri Paesi, penso per esempio alla Francia, dove passo la maggior parte del tempo. Per me questa scelta non è negoziabile, è inconcepibile che il lavoro culturale non sia retribuito e quindi non ammetto la gratuità dei contenuti. È fondamentale la retribuzione equa del lavoro culturale e simmetricamente si spera che i lettori siano ricettivi rispetto a questa esigenza, dimostrandosi disponibili a pagare per i contenuti qualora li ritengano interessanti. Abbiamo incontrato meno difficoltà di quante ce ne aspettavamo, avevamo in progetto di rientrare dei costi entro il terzo anno e ci stiamo riuscendo. Le persone che amano i nostri contenuti tendono ad abbonarsi. Noi abbiamo pochissimi contenuti accessibili in chiaro (spesso sono i contenuti della sezione Finzioni e pochi articoli per chi è iscritto gratuitamente alla newsletter). Non credo nei contenuti speciali a pagamento, è necessario che quasi tutti i contenuti abbiano un paywall.

Leggendo la presentazione di Snaporaz dal vostro sito emerge la volontà di fare critica, in opposizione a una tendenza diffusa del giornalismo culturale italiano. Snaporaz fonda le proprie pubblicazioni su un nucleo “fisso” di collaboratori e collaboratrici (fra gli altri, Gilda Policastro, Guido Mazzoni, Gianluigi Simonetti, Matteo Marchesini, Sofia Torre, Emiliano Morreale) che danno un’identità riconoscibile alla rivista e al suo posizionamento nella cultura. Quanto è importante per voi questa riconoscibilità?
Quello che ci distingue dalle altre riviste online a noi comparabili è che abbiamo puntato dall’inizio a formare un nocciolo duro, sebbene abbastanza ampio, di firme ricorrenti, che avessero un certo spirito critico, un registro, un tono identificabile. Questo rende Snaporaz più riconoscibile rispetto a riviste che nell’arco di un mese pubblicano ogni giorno autori differenti. Il lettore di Snaporaz nello stesso arco di tempo troverà facilmente un paio di articoli delle persone che hai citato. Accanto a questi e altri nomi ci possono essere collaborazioni episodiche o più saltuarie. Come accade negli inserti culturali veri e propri, tenevamo molto alla presenza di questo nucleo.
Parliamo del rapporto tra la critica e internet: non parlo soltanto dei social, ma di una dimensione più ampia che ha le sue regole, i suoi tempi e i suoi spazi e formati, molto diversi da quelli della critica tradizionale. Per molto tempo si è parlato di morte della critica, eppure secondo me sarebbe più importante chiedersi in quali forme la critica oggi può essere incisiva. Voi ci avete riflettuto? È necessario che la critica si adegui alla rapidità del digitale o piuttosto bisogna trovare il modo di far convivere le esigenze dell’una e degli altri?
Sono convinto che ci debba essere un primato assoluto della critica di per sé. A noi non importa rincorrere le novità o recensire un libro in modo tempestivo soltanto perché se ne è parlato sui social o altrove. Abbiamo una visuale sulla letteratura che è diversa da quella del discorso comune online. L’unica cosa essenziale è che il nostro discorso critico si svolga su due piani: da un lato, valorizzare cose di cui non si è parlato abbastanza; dall’altro, in modo speculare, parlare male di ciò di cui si parla bene a torto. Se non si stronca nessun libro, se non si condanna la pochezza di certi prodotti culturali spacciati per grande arte, difficilmente si guadagna legittimità critica. Forse Snaporaz è percepita come una rivista che tende principalmente alle stroncature, ma in realtà sono di più le recensioni positive. Quelle negative, tuttavia, sono indispensabili e sono più notate dal pubblico, perché sono meno praticate dagli altri.
Per quanto riguarda la questione della rapidità del digitale, la si può intendere anche in termini di velocità di lettura. Io personalmente non sono un amante dei longform e non credo che le recensioni debbano superare un certo limite di battute. Prediligo una scrittura concisa, che rispetti una certa misura. Posso constatare che, a parte rare eccezioni di autori che hanno bisogno di un certo spazio per esprimersi con compiutezza, mediamente i collaboratori danno il meglio sul piano della scrittura e dell’elaborazione del pensiero quando hanno dei limiti di spazio. Su Snaporaz pubblichiamo tendenzialmente pezzi tra le seimila e le ottomila battute. A posteriori, questo su internet dà dei vantaggi, perché difficilmente i pezzi troppo lunghi vengono realmente letti, vengono appena scorsi. Ma le ragioni per cui pubblichiamo pochi longform sono altre, quelle di cui ho appena parlato. A noi interessa che i pezzi che pubblichiamo siano pensati con rigore, scritti con stile e davvero letti. Davvero letti significa che l’unico dato che conta per noi è quello del numero degli abbonati. Le visualizzazioni e il traffico sono invece dati di per sé senza molto senso, contano per chi vende spazi pubblicitari (ed è questo che rende la qualità media degli articoli dei giornali molto bassa, ad esempio). Lo stesso traffico che arriva dai social è spesso effimero, le sponsorizzate che talvolta abbiamo fatto, per esempio, non hanno mai aumentato in modo significativo il numero di abbonati. Ciò che conta per noi è il desiderio delle persone di leggere la rivista, quindi arrivare ai lettori “giusti” per Snaporaz. Gli altri lettori non ci interessano.

In questa serie di interviste analizziamo anche i motivi che hanno portato alla chiusura delle riviste. Ora, quindi, ti chiedo: al di là di eventuali condizioni materiali che possono portare alla fine del progetto, quand’è che Snaporaz secondo te non avrà più senso di esistere?
È difficile da prevedere. All’inizio del terzo anno di Snaporaz ho avuto la sensazione che ci fosse bisogno di un rinnovamento all’interno della rivista. Avvertivo una sensazione di staticità rispetto al progetto, per questo sono stato contento di aver avviato il cartaceo. Probabilmente faremo anche un nuovo sito. Sentiamo la necessità di non lavorare sempre allo stesso modo, di cercare nuovi collaboratori, e di affinare sempre di più la programmazione. Però, certo, con il cambiare dei tempi una rivista può perdere la sua ragione di esistere. In questo senso, se un giorno fosse chiaro che un certo tipo di critica non interessa più a nessuno, o se tutti decidessero di fare certa critica, si dimostrassero capaci di farla e quindi ci fosse troppa offerta (cosa di cui dubito fortemente), noi forse non avremmo più motivo di esserci. Insomma, credo che finché resteranno lettori che non si accontentano di una pseudo-critica culturale prevalentemente improntata a forme di promozione, e principalmente praticata da personaggi un po’ pavidi, o un po’ ignoranti e cialtroni, Snaporaz continuerà ad avere un senso.