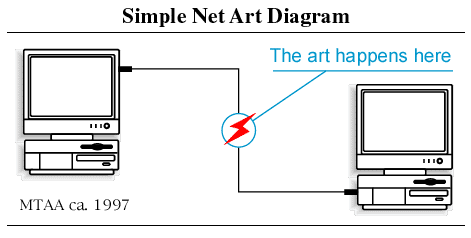Colonizzare l’immaginario. Sembrava impossibile, eppure basta disporre degli strumenti opportuni. Televisioni, mass-media, una stampa docile, un trend culturale. Finisce che intere generazioni si trovano immerse in un sogno, e lo scambiano per realtà. Ora, quali sono le caratteristiche di un sogno? Che si vive una vicenda priva di antecedenti e di conseguenze nel futuro. Esiste il presente e basta.
Valerio Evangelisti, Carmilla n°1
Quando nel 1995 Valerio Evangelisti scrive l’editoriale del primo numero di Carmilla, la sua nuova rivista culturale, dice: siamo nello stato del sonno profondo e quindi del sogno. Come Kenue Reeves nutrito dalla matrice (capitalista) nel suo bozzolo gelatinoso (“televisioni, mass-media, una stampa docile, un trend culturale”), per noi esiste solo questo eterno presente post-moderno che si autoavvera nella fruizione dei suoi contenuti, nel nostro consumare da consumatori, oltre ciò: nessun passato, nessun futuro.
Convinti che solo grazie alla conoscenza del passato siamo in grado di prospettare un futuro, la redazione di Stanca ha deciso di guardarsi indietro per fare qualcosa di nuovo: scrivere una storia delle riviste culturali online. Sarà questo un progetto di ricerca editoriale in cui saremo impegnate nel 2025: pubblicheremo nei prossimi mesi interviste e articoli teorici sulla storia e sull’attuale panorama delle riviste culturali online italiane.
Questo editoriale vuole essere contemporaneamente un’introduzione generale al tema e al nostro lavoro di ricerca, è diviso in quattro sezioni: la prima definisce la rivista culturale, la seconda si concentra sul suo passaggio dal supporto cartaceo all’online, la terza scandisce nel tempo lo sviluppo delle riviste culturali online in Italia, nella conclusione descriviamo la motivazione politica alla base della nostra ricerca.
La rivista culturale
La parola rivista, dal francese revue che a sua volta traduce l’inglese review, deriva dall’omonimo genere di spettacolo teatrale in voga alla fine dell’Ottocento in Francia: un misto di musica, canto, danza e prosa, che mette in scena una serie di quadri o scenette di intonazione comica, ironica o satirica, ispirati all’attualità. Nel passaggio dal teatro alla carta stampata la rivista mantiene questa attitudine alla rassegna del quotidiano e all’accostamento di temi eclettici. La pubblicazione delle riviste avviene sempre in forma periodica (settimanale, mensile, semestrale) e può contenere articoli di forma, registro e lunghezza diversa.
Possiamo considerare una rivista culturale quella che, abbandonata la sua funzione di puro intrattenimento, si propone come strumento di produzione del dibattito culturale: generandone i temi, orientandone la direzione e fornendo gli strumenti complessi per parteciparvi. Chi gestisce o partecipa a una rivista culturale è un intellettuale che ha interesse nell’analisi, nella critica e nella manipolazione della cultura in un determinato contesto spazio-temporale, rivolgendosi a un pubblico che vuole comprendere e discutere le sue argomentazioni. Possiamo quindi definire la rivista culturale come lo strumento di comunicazione tra gli intellettuali e una cerchia di pubblico composto dai lettori della rivista. La storia e le metamorfosi della rivista culturale in Italia seguono in maniera mimetica quella di tutta l’editoria periodica, di cui attraversano i cambiamenti sociali, culturali e materiali: primo fra tutti la rivoluzione digitale. L’origine della transizione digitale dell’editoria periodica a cui abbiamo assistito nell’ultimo quarto di secolo può essere rintracciata in una data precisa: il 30 aprile 1986, quando avviene il primo collegamento internet in Italia. Undici anni più tardi, il 14 gennaio 1997, La Repubblica lancia la versione web del suo quotidiano in cui compaiono articoli non presenti nella versione cartacea; è tracciato così il percorso che nel giro di pochi anni avrebbe mutato definitivamente il medium editoriale. Nei dieci anni successivi il progressivo assottigliamento della produzione periodica – con il conseguente svuotamento delle edicole, che ne rappresentavano ancora il principale punto di distribuzione – corrisponde a una migrazione dalla carta stampata al digitale.
Le riviste culturali seguono un percorso simile, influenzato anche da altre profonde trasformazioni sociali difficilmente districabili: la crisi della mediazione editoriale e della figura dell’intellettuale, la frammentazione del dibattito culturale con l’avvento delle televisioni private e poi del web, il nuovo paradigma politico italiano dopo la seconda repubblica.
La rivista culturale online
Le riviste culturali online si avvalgono principalmente del supporto digitale e sono distribuite tramite web. Cominciano a diffondersi in Italia nei primi anni ’00 e rispecchiano l’esordio di nuovi movimenti culturali in un web che non ha ancora permeato l’intero tessuto sociale, in cui la partecipazione spontanea e dal basso è ancora il motore principale della produzione di contenuti. Il formato degli articoli che caratterizza ancora oggi la quasi totalità delle riviste culturali online è il longform anglosassone, articolo di approfondimento culturale medio-lungo (anche oltre le 20.000 battute) che avvicinandosi alla forma del saggio breve permette di conciliare la profondità di analisi critica con la ricercatezza stilistica e il sincretismo dei temi trattati.
L’evoluzione delle riviste culturali online
Abbiamo deciso di dividere la storia delle riviste culturali online italiane in quattro fasi principali, quattro ere che seguono i cataclismi e le mutazioni subite dal web durante questi anni:
Fase sperimentale
È la prima fase embrionale che va dal 2000 al 2008. Nelle riviste culturali appaiono i primi tentativi di ibridazione con la nuova tecnologia della rete digitale. Questo mutamento, nonostante un web agli albori, ancora nettamente diviso tra una massa sempre più ampia di fruitori di contenuti online e pochi produttori (è ancora indispensabile la conoscenza del linguaggio HTML), appare vantaggioso alle riviste: permette di abbattere i costi di stampa e raggiungere contemporaneamente un bacino di possibili lettori digitali molto più ampio del cartaceo. Scompaiono così le limitazioni spaziali che ostacolano la circolazione delle riviste (in particolare quelle artigianali e a basso costo), le uniche barriere diventano quella linguistica e quella socio-economica della disponibilità di un accesso a internet.
Mostro, una fanzine creata nel 2000 da un gruppo di studenti universitari a Firenze, carica periodicamente sul suo sito web un file in formato pdf liberamente scaricabile della rivista. Nonostante la sua impaginazione sia ancora progettata per la fruizione cartacea, l’innovativa distribuzione online permette di riconoscerla come l’archetipo delle odierne riviste culturali online.
Carmilla, la rivista culturale fondata da Valerio Evangelisti nel ’95, dal 2003 decide di convertirsi al digitale pubblicando gli articoli su un sito web che, per quanto ancora rudimentale, abbandona del tutto il formato cartaceo per il formato blog, è il primo esemplare di una nuova specie.
Nazione Indiana invece è la prima pensata già digitale. Fondata nel 2003 da Carla Benedetti, Antonio Moresco e Tiziano Scarpa, scrittori e intellettuali già affermati, ha l’intento programmatico di “far saltare il filtro dei mediatori culturali”. La sua genesi, che avviene in un convegno indetto dai tre fondatori a ridosso delle proteste per il G8 di Genova segue lo zeitgeist degli anni ’00: un tecno-ottimismo intriso di velleità anarchiche che vede nella diffusione del web un possibile detonatore delle gerarchie sociali e culturali. Ambizione questa che rimarrà quanto mai frustrata – oggi possiamo affermalo purtroppo con certezza – e che servirà semmai a ristabilire nuovi rapporti di potere dopo una fase creativa di assestamento.
Fase blog
La seconda fase si sviluppa dal 2008 al 2015 grazie all’esordio del web 2.0 e la sempre maggiore diffusione di piattaforme gratuite di blogging. Proprio il blog è stato il formato protagonista delle prime fasi di ampia diffusione del web perché permetteva una facile produzione e diffusione online di contenuti senza richiedere quelle competenze informatiche specifiche che, come abbiamo visto, erano indispensabili invece ai suoi esordi.
È grazie a questo strumento che nascono e si consolidano le forme più diffuse di rivista culturale online: un blog fondato e gestito da un gruppo di intellettuali, a volte molto giovani (Finzioni, 404: file not found), oppure che gravitano già attorno a una realtà culturale preesistente (minima&moralia). Vogliono proporre articoli che faticherebbero altrimenti a trovare un posto nell’editoria cartacea ufficiale a causa delle logiche economiche e di gatekeeping che la caratterizzano, e decidono così di fondare sul web un proprio spazio con una proposta alternativa.
Caratteristica di questo periodo è la presenza nelle riviste di una sezione commenti che permette di dialogare direttamente con la redazione creando uno scambio inedito tra scrittore e lettore. La differenziazione tra produttore e fruitore di contenuti online incomincia ad assottigliarsi proprio ora: il web 2.0 è in questo senso il momento di massima orizzontalità della rete, quello in cui le promesse di diffusione gratuita della cultura e del dibattito sembrano avverarsi. Questa illusione verrà spazzata via in tempi brevi: l’avvento dei social network porterà a compimento la definitiva omogeneizzazione tra la figura del produttore e quella del consumatore, instaurando in maniera più o meno occulta nuove dinamiche di proprietà e sfruttamento all’interno della rete, gettando le premesse dell’odierna gerarchia di potere del web che influenzerà profondamente le riviste culturali online delle fasi successive.
Fase social
Questa fase, che va dal 2015 al 2020, vede le riviste culturali che nascono in questo periodo trovare un adattamento all’inedito ecosistema creato dal social network allora in maggiore espansione: Facebook. L’algoritmo in uso dalla creatura di Zuckerberg nutre in maniera esponenziale la diffusione degli articoli, grazie alle interazioni portate dai mi piace, dai commenti e dalle condivisioni. In questo nuovo e sterminato territorio digitale si allarga a dismisura il bacino di lettori che non sono più costretti a scovare il dominio, ma vengono in contatto, spesso involontariamente, con gli articoli direttamente dal feed. In breve tempo la vita delle riviste incomincia a scorrere più velocemente, moltissime nascono e ristagnano nel giro di mesi, alcune riescono a imporsi e a prosperare in questo ambiente dalla competitività sempre più elevata.Tra queste, le più importanti ancora oggi sopravvivono: Doppiozero, L’Indiscreto, Il Tascabile, Not.
Escludendo Doppiozero, nata da un progetto di docenti universitari, è interessante notare come le riviste più importanti che abbiamo citato in questa fase abbiano tutte fonti di finanziamento alternative che ne permettono la sostenibilità economica: mente L’Indiscreto e il Tascabile dipendono economicamente da istituzioni storiche impegnate nell’ambito culturale (rispettivamente la Casa d’Aste Pananti e la Fondazione Treccani), Not ha alle sue spalle la casa editrice Nero che prima di aprire la sua linea editoriale alla theory fiction e alla critica culturale più avanzata, produceva già da anni libri legati al mondo all’arte contemporanea.
Fase imprenditoriale
L’ultima fase, dal 2020 a oggi, è fortemente influenzata dalle mutazioni avvenute nei social network. L’arrivo della pandemia sembra dare l’impulso definitivo alla capillarizzazione nel quotidiano dei social che, a causa delle limitazioni alla libertà di movimento imposte dal governo, diventano il più importante mezzo di comunicazione tra la solitudine domestica e il mondo esterno. Anche le riviste online giovano di questo momento tristemente propizio per la comunicazione online e raggiungono proprio durante la pandemia il massimo livello di diffusione e interazioni con gli articoli. Proprio mentre si raggiunge l’apice di questa simbiosi strutturale di riviste e social network però, un profondo cambiamento in questi ultimi è già in atto (anche se solo oggi è possibile comprenderne a pieno le conseguenze): l’algoritmo viene radicalmente modificato in funzione di un’incremento della visibilità per gli influencer (produttori di contenuti creati ad-hoc per la viralizzazione) e i contenuti sponsorizzati; contemporaneamente avviene una riduzione dell’influenza delle interazioni sulla visibilità dei post. Facebook entra in questo momento nel suo periodo di senescenza, l’età media si alza sempre di più, il feed si satura di contenuti di bassa qualità, molti degli utenti più giovani danno priorità a Instagram e Tiktok.
Le modifiche imposte dall’algoritmo colpiscono entrambi i social di Zuckerberg: su Facebook, le interazioni tra utenti, le condivisioni e le pagine che producono post perdono sempre più la loro visibilità in funzione dei gruppi che scambiano internamente contenuti tematici simili; su Instagram il feed dà sempre maggiore spazio alla diffusione di contenuti video come le storie e i reel.
Per le riviste che avevano fatto di Facebook la loro infrastruttura principale è un cataclisma epocale. Mentre le interazioni con i post crollano, le riviste che riescono a mantenersi attive lo fanno solo grazie alla possibilità di un finanziamento esterno o al crowdfunding, alle newsletter e alla risonanza delle loro firme più conosciute.
Instagram appare intanto come un territorio ostile alla diffusione degli articoli: la possibilità di linkare a pagine esterne è estremamente limitata (è possibile farlo per un link soltanto dal profilo ma non sui post, e proprio per questo nascono gli aggregatori di link), inoltre il social si basa interamente sulla diffusione di contenuti visuali, le immagini e i video assumono così un’importanza centrale nella diffusione degli articoli.
In una situazione tanto mutata in tempi così brevi, le riviste che nascono in questo periodo rivoluzionano completamente quei caratteri comuni che fin qui abbiamo descritto, due in particolare sono utili oggetti di questa analisi: Snaporaz e Lucy. Snaporaz nasce nel 2022 introducendo fin dal suo esordio online un cambiamento epocale nella sua struttura economica: il paywall. Già adottato dalla maggior parte dei quotidiani online, è la prima volta che in Italia una rivista culturale sceglie deliberatamente di diffondere i suoi contenuti soltanto a pagamento. La ricerca di una nuova forma di sostenibilità economica che garantisca anche un’alta qualità degli articoli guida questa scelta, poiché Snaporaz non ha alle spalle nessuna fondazione per finanziare il lavoro di redazione e dei contributori. Anche il rapporto con i social cambia radicalmente, la rivista è pensata per essere integrata con la comunicazione di Instagram, su cui pubblica i post dei propri articoli e una videonewsletter attraverso i reel.
Lucy nasce nel 2023 ed estremizza la strada illustrata da Snaporaz portandola verso un approccio ancora più imprenditoriale, tanto che è difficile considerare oggi Lucy una rivista culturale pura, quanto più una casa di produzione di contenuti multimediali, tra cui gli articoli culturali. Dopo un periodo di diffusione gratuita anche Lucy opta per il ricorso al paywall ma la maggiore discriminante rispetto alle riviste analizzate fino a ora è il suo rapporto con i social e la sua produzione di contenuti. Oggi Lucy pubblica accanto ai suoi articoli anche due newsletter e due podcast, una sezione di articoli tematici (a pagamento), un magazine cartaceo. Su Instagram la mole di contenuti è incessante: videointerviste a scrittori e intellettuali, recensioni cinematografiche, libri e film consigliati, una rubrica che analizza i disegni dei bambini, una selezione di racconti e una raccolta di video curiosi e divertenti trovati su internet; Lucy tiene anche corsi di scrittura e un festival a Roma. Tutti questi contenuti portano visibilità e clienti alla rivista che diventa così a tutti gli effetti un’attivitàimprenditoriale che orienta le sue scelte in base alla remuneratività e al mercato.
Ci sembra interessante e accurato concludere la carrellata storica sulle riviste culturali online italiane con Lucy, una rivista che sembra contemporaneamente contenere e superare la definizione di culturale. Se da un lato ne è l’evoluzione più avanzata e multiforme che sia mai apparsa sul panorama italiano, contemporaneamente porta con sé tutte le ombre e le contraddizioni di un sistema che non può che soffrire una serie di limitazioni congenite.
Prima tra tutte l’instabilità o insufficienza economica dovuta in larga parte all’assoluta carenza di fondi pubblici, fatto che penalizza le esperienze più avanzate di produzione culturale in funzione dei pachidermici relitti della vecchia editoria cartacea. Si somma a ciò la scarsa indipendenza dai social media che sono oggi a tutti gli effetti l’unico canale di visibilità delle riviste online, la cui attività deve tener conto delle regole imposte dall’algoritmo. Tutto questo comporta il progressivo e ineluttabile abbassamento della qualità dei contenuti culturali, frustrati da una incessante richiesta di pubblicazione, qualità della proposta e accessibilità della stessa, di fronte però a una retribuzione per chi scrive sempre più scarsa. Insomma, si genera una caduta tendenziale del profitto che rende il sistema delle riviste culturali online sempre meno sostenibile, condannandole alla sparizione o alla trasformazione in forme nuove, come forse Lucy già dimostra.
Rivista Stanca crede nella necessità impellente di una storia critica delle riviste culturali online, da cui oggi dipende una parte preziosa del nostro sistema culturale. Ci poniamo così al termine di questa lunga catena di esperienze, proponendoci di farne nostre le intuizioni migliori e di non ripeterne gli errori e le degenerazioni. Crediamo in una cultura libera, lottiamo attivamente per la sua diffusione e accessibilità. Il capitalismo oggi, tra le sue diverse aberrazioni, ha quella di una sempre maggiore alienazione della persona dalla conoscenza, attraverso la recinzione, l’occultamento o la corruzione di quest’ultima. Rivista Stanca persegue il progetto culturale, etico e politico di ricomporre la persona con la conoscenza, contribuendo così a un ulteriore passo verso la sua liberazione.