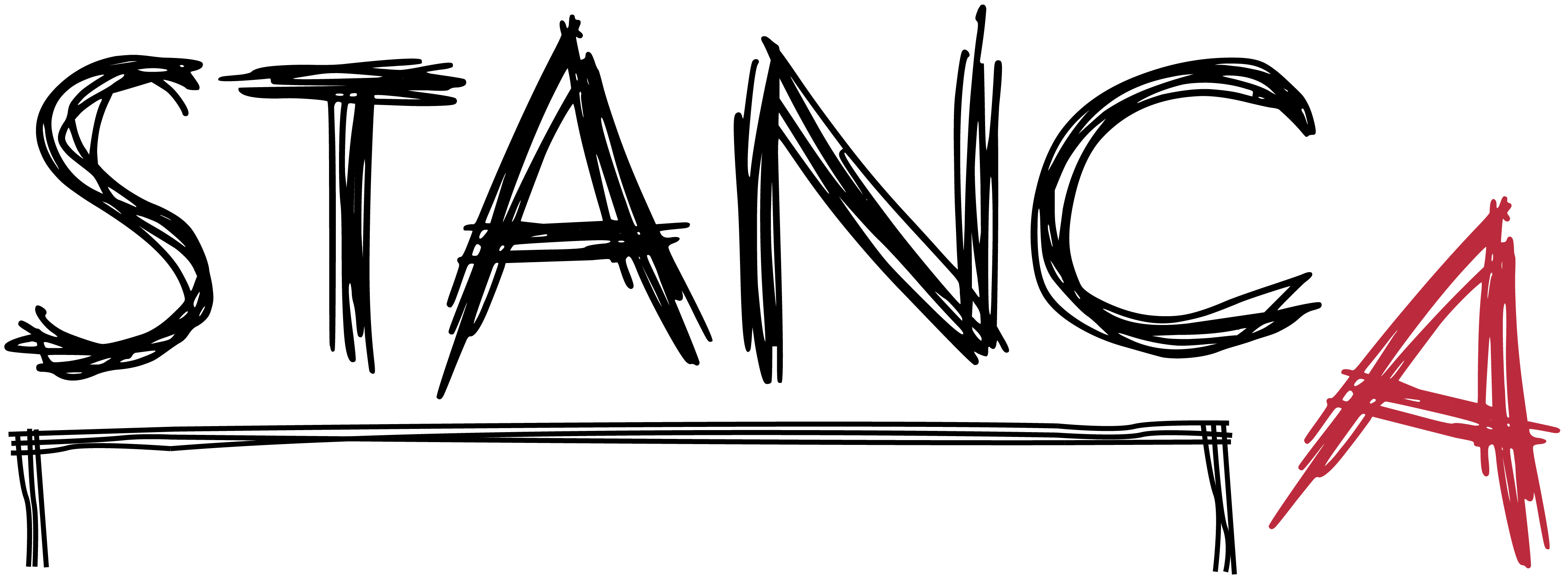Sono stanca di dover decidere se farmi leggere oppure se esprimermi sui profili social che sono riconducibili a me. Proverò a spiegare nel modo migliore possibile quello che sento.
A volte mi nasce una frustrazione incommensurabile ed è una sensazione fisica: la percepisco in una zona non ben definita tra la testa e il petto. Capita che quando questo accade io sia reduce di scrolling o di qualche altro tipo di sfogo compulsivo contemporaneo legato alle piattaforme – soprattutto, mi capita quando leggo cosa dicono o pensano gli altri riguardo alle faccende del mondo. Questo mi succede perché in automatico quelle informazioni si scontrano con me e le mie credenze, delineano le differenze e le somiglianze con le identità di tutti quelli che non sono io.
Incontrare gli altri online, presentare me stessa online, sapere di poter lasciare fuori da questa nuova identità le imperfezioni del corpo e del tempo reale, essere spronata a mentire, o meglio, a creare un’altra me ma non proprio me, poter dire e cancellare, avere la possibilità di tenere me stessa sotto controllo e sapere che anche a tutti gli altri questo era concesso… per me è stato molto difficile.
Da quando ho iniziato a pubblicare sui miei profili social è diventata sempre più limpida e lucida la consapevolezza di non essere fatta per questo, da subito si è affiancata a questa sensazione di inadeguatezza la certezza che non lo fosse nessuno.
Quello che condividevo di me con gli altri online era stato presto motivo di angoscia o imbarazzo: via via che cambiavo – crescevo – ridefinivo i confini della mia sfera intima e così, inevitabilmente, si andavano a formare altri limiti al condivisibile, diversi, nuovi, più maturi o più sprovveduti in base a com’ero diventata. Le scelte del passato, cristallizzate sui miei profili social, diventavano a questo punto monito di un’esperienza traumatica.
Probabilmente tutta la spiegazione fin qui può apparire criptica, lo capisco bene. È difficile parlare dell’esperienza che facciamo con gli altri online soffermandoci sulla zona d’intersezione che ha con la realtà, con la sua percezione e con la nostra identità. Ma personalmente è sempre in questo intermezzo sfumato che mi si sono creati grovigli di irrisolto particolarmente frustranti.
Ho sempre rincorso e ambito a una vita il più possibile sconnessa dal pensiero degli altri sui social. Non è mai stato un fioretto facile da mantenere, piuttosto una credenza di autoconservazione che metteva in pratica il mio cervello per tenersi al riparo da cose che non era pronto a elaborare.
La condivisione dei pensieri sui social è sospesa dalle faccende che riguardano la fisicità e il contesto è – quasi sempre – autoreferenziale. Questo rende l’approccio allo studio delle identità e delle loro rappresentazioni estremamente faticoso perché richiede metodi di indagine sociologica, antropologica e psicologica nuovi e ultrasensibili. Alla triennale scrissi la tesi su questo argomento – era il 2019 – solo dopo riuscii a scaricare Instagram. Letteralmente il mio incubo, il social che più di tutti mi obbligava a parlare di me, sul mio profilo, non includendo nessun altro.
Studiare aiuta ad alleggerire la frustrazione scaturita dalle cose che non si comprendono bene, ma nonostante ciò questi argomenti mi hanno lasciato spesso confusa e stanca, devastata dalla sensazione che ci fosse qualcosa – una mancanza – che mi impedisse di vivere queste interazioni con gli altri, con le loro dichiarazioni o con i loro flussi di coscienza in modo migliore.
Uno dei riflessi condizionati che concretizza l’agire di questo mio faticoso lavoro sinaptico è l’irrefrenabile voglia di esprimermi sulle piattaforme. Negli anni ho imparato abilmente a castrare questo bisogno anche utilizzando una buona dose di auto coercizioni psicologiche. Le più emotive di tutte erano basate sul farmi sentire non all’altezza di postare, la tattica era tanto funzionale quanto a lungo andare dannosa.
Il desiderio di comunicare all’esterno quello che si prova credo sia del tutto sano. Dopo aver letto qualcosa o essere finalmente giunti a delle conclusioni personali rispetto a una questione che ci tormentava, non solo è bene, ma è addirittura stimolante parlarne con gli altri: abbiamo necessariamente bisogno di confrontarci con i pareri esterni.
Il dibattito ci appassiona e risulta gratificante, ma non sempre sui social è così. Anzi, le volte in cui l’esperienza di dialogo pubblico online è produttiva sono molto poche, la piazza virtuale è scoppiettante di tutto fumo e niente arrosto. Sta trollando? pensa veramente queste cose? sto parlando con qualcuno dotato di un quoziente intellettivo adeguato per comprendere i miei messaggi? è un bot?
E qui incomincia il dilemma della zona grigia tra realtà fisica e realtà digitale. Quando non si riesce a trovare un punto di partenza in comune, fino a che punto è necessario rispondere? E soprattutto, in che modo? quanto valgono qui le regole dell’educazione, della morale, del rispetto?
Non è stato subito chiaro per me, ci ho messo un po’. Come dicevo anche prima, attorno all’idea che ho di postarmi sui social ha sempre aleggiato una fitta nebbia di scrupoli. Con chi mi sto condividendo? cosa so rispetto all’opinione che potrebbe farsi di me il mio anonimo interlocutore? o cosa penserebbe il mio datore di lavoro del 2012 se postassi questa foto con il cane? o con la tipa? oppure, che succede se rispondo a questo coglione che fa l’ennesimo walltext sulle cose che lo infastidiscono della nuova giunta comunale? o se metto ‘sta pic con Hitler ma di quelle sfumate, potrei dire quasi vaporwave?
Quando, verso i 20 anni, ho iniziato a fare queste riflessioni ho semplicemente deciso che avrei smesso di postare qualsiasi cosa riguardasse la mia vita. Sui miei profili ero una reminiscenza spirituale della vera me: musica, poesia e meme.
Il dilemma si è ripresentato quando ho capito che avrei dovuto riprendere a parlare, se non direttamente di me, almeno del mio lavoro: nuovo obbligo per chi sceglie di percorrere la dannata strada dell’autoproduzione. Devi esistere e raccontarti – oh no, di nuovo – a tutti loro. Chi cazzo siete? dovevo eliminare i meme più ambigui per parlare del mio lavoro?
Dovevo fare una lista “amici più stretti”, dove postare le cose che non mi andava di far vedere a tutti. Sarebbe stata un’ottima idea, se solo non avessi fiutato la possibilità di comunicare tra le righe la mia inarrestabile voglia di farmi quel selfie e farlo vedere, o di stupire una quantità ristretta di gente perché ero stata la prima di ig italia a condividere l’ultimo post di disturbing zone. Ma poi, ‘sta lista, comunque non è che potevo postarci tutto tutto. I selfie li risparmiavo a tutti, smettevo pure di farmeli approfittando di un periodo depressivo più leggero. I meme anche, a sto punto li mandavo direttamente in privato alle persone che volevo li vedessero senza postarli. Ridefinivo i confini del pubblico, li disegnavo astratti ma più vicini a me. Alla fine il metodo delle storie speciali ha funzionato un paio di volte, poi mi sono rotta il cazzo.
Attualmente posto con parsimonia e i miei mantra sono: quel che è stato è stato; mostrerai solo i tuoi saperi, mai i tuoi dubbi; se leggi una cosa e ti sembra sensata ma non troppo, non mettere like, potrebbe essere molto più controversa di quanto immagini e il tuo like rimarrebbe, tutelati; se leggi una cosa e ti sembra molto sensata devi restare in osservazione, impara a capire chi c’è dietro l’account, a volte se sei fortunato può capitare di sentire una bella energia, ma ricorda che è pur sempre una rappresentazione; like ai tuoi amici più in vista; profilo privato se sei un serial killer, hai un brutto mental breakdown o sei un egocentrico dei follower; quello che vedi può essere sempre finto e se leggi cose assurde immagina che stiano trollando.
Stanno sicuramente trollando. Quando scrivo di getto qualcosa anche io sto trollando, o almeno è come me la spiego.
Sono sempre stati troppi per me i pensieri che facevo circa il giudizio degli altri, online mi è da subito sembrato che qualsiasi cosa facessi per esprimermi potesse più avanti rivelarsi un mio punto debole. L’album dei ricordi eternamente consultabile rende difficile lasciarsi andare all’impeto delle emozioni senza pensare alle conseguenze, ma allo stesso tempo rende una mossa inaccettabile quella di cambiare troppo le proprie idee. Ci sarà stato qualcuno attento? qualcuno si ricorderà come la pensavo?
La risposta sospesa, la reazione potenziale che gli altri hanno davanti ai nostri post e a noi preclusa mi rende impossibile esprimermi. A quale me hanno reagito? Quando rimarrò da sola con me stessa saprò convivere con tutte le identità che posso forgiare? e quante di queste saranno in conflitto con la fisicità del mio corpo, con le cose che non si possono cancellare? Dato l’uso crescente che facciamo dei social, per quanto sarei in grado di sostenere la moltiplicazione esponenziale delle situazioni in cui poter provare imbarazzo, rabbia o vergogna?
Quasi la totalità delle volte mi faccio leggere, scelgo con cura una frase che mi va bene venga fraintesa. Non ci tengo tanto che la capiscano tutti; l’espressione di me, dei miei intenti, rimane in secondo piano rispetto all’azione di comunicare quell’informazione, quel brano, quel paesaggio.
Può sembrare io abbia raggiunto un grado di consapevolezza accettabile ma sostenerlo mi affatica in maniera vergognosa. Vivo ancora con malessere quei momenti in cui sacrifico lo spazio che avrei dedicato alle mie battaglie e alle mie rabbie, per cederlo alla vendibilità della mia identità: ovvero le fondamenta per edificare la safe zone dell’internet abitabile.