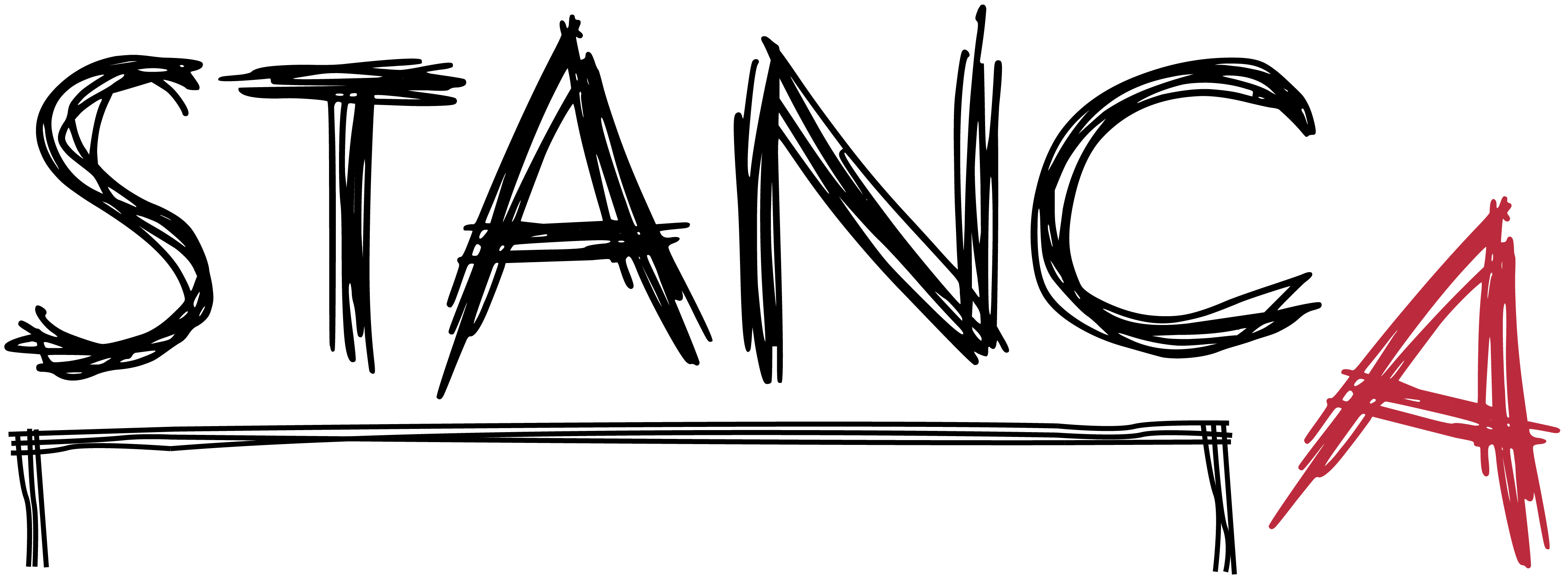Takeshi Kitano è uno dei registi giapponesi più rilevanti della storia del cinema. Nelle sue pellicole paura, morte e gioco si confondono e si esplorano in un teatro di simboli in cui il viso totemico del regista si fa maschera del dolore e della sopraffazione, dell’inevitabilità della vita, dove quest’ultima conduce sempre alla tragedia. Kitano pesca dalla sua autobiografia elementi che caratterizzano le sue pellicole, spesso abitate da alcolizzati ludopatici e da mafiosi, la yakuza è al centro di quasi tutti i suoi film.
Autore celebre in patria per l’enorme successo di Takeshi’s Castle – il famoso gioco a ostacoli con premi in palio – e per la sua carriera televisiva da stand up comedian, vive parallelamente negli anni ‘80 una parentesi da attore nel cinema giapponese, ma ricoprirà un ruolo di spessore internazionale solo in Merry Christmas Mr. Lawrence di Nagisha Ōshima, conosciuto anche con il titolo Furyo, che vede la partecipazione di David Bowie.
Violent Cop segna il suo esordio come regista, seguito da Boiling Point, in cui iniziamo a percepire un afflato simbolico che esploderà del tutto solo nei suoi film successivi. I sintomi di un linguaggio più aulico, mescolato a dialoghi stradaioli e alle vicissitudini di sgangherati personaggi alla deriva, porterà il suo cinema a un livello ulteriore nell’ideale triade che racchiude Sonatine (1993), Hana Bi (1997) e L’estate di Kikujiro (1999).
Tre opere in cui ricorre l’elemento della paura, è la vita stessa che la esalta, e in ognuna Kitano opera una cesura apparente tra realtà e illusione, tra battaglia e fuga. Per Kitano la battaglia è la morte onorevole, lo spregio della paura che porta sì a una fine inevitabile e tragica, ma pregna del significato stesso della vita, mentre la tragedia è la battaglia senza vittoria. Il sogno rappresenta invece l’elemento fondativo dell’umano, illusione e motore del cursus vitae, l’ancorarsi all’elemento divinatorio e imperscrutabile di una vita altra che non sia solo la summa di rimpianti e rimorsi; ma in ‘quel tempo’, prigionieri nello spazio del sogno, che può essere la spiaggia in Sonatine o la strada come viaggio in Hana Bi e L’estate di Kikujiro, “Tutto è davanti a me, e tutto è ancora possibile” come dice Tarkovskij tramite il suo alter-ego in Lo specchio.
Tre storie, tre trame dissimili eppure concordanti: in Sonatine viviamo il viaggio di uno yakuza verso la sua ultima missione prima del pensionamento, che avrà risvolti imprevisti e letali per lui e la sua banda; in Hana bi seguiamo un poliziotto circondato e segnato dalla morte e dalla malattia, che lo spingono a rivolgersi alla yakuza per contrarre debiti che non potrà o non avrà bisogno di ripagare; in Kikujiro, possiamo solo dedurre che il nostro sia stato uno yakuza e che proprio il suo passato lo abbia reso il bambino troppo cresciuto che incontriamo per tutta la prima parte del film, a cui viene affidato il compito di accompagnare un ‘vero’ bambino, Masao, alla ricerca della madre.
Storie di yakuza e sogni infranti
Se in Sonatine e Hana Bi è il terrore del futuro ineluttabile a farla da padrone, L’estate di Kikujiro recupera gli elementi primigeni della carriera di Kitano, retaggi del suo passato da comico – l’unico background che il suo stesso popolo gli riconosce – e innesta una dose più massiccia di ironia attraverso tutto il tessuto narrativo, lasciando agli eventi più malinconici e dolorosi il ruolo di turning points, snodi narrativi di un atipico road movie. Il film racconta il viaggio di un bambino, Maseo, alla ricerca della madre, accompagnato da uno yakuza, Kikujiro. Lo yakuza diventa adulto, “padre”, si mescola e confonde con la figura di Masao – “siamo uguali io e te” – e tramuta la sua arroganza iniziale in consapevolezza attraverso il viaggio e una serie di gesti che il nostro sembra considerare inutili, oppure già acquisiti (il tip tap, il gioco delle tre arance, il nuoto) ma in cui lentamente inizia a cimentarsi scavalcando l’ignoto e acquisendo una sicurezza che diverrà presto maturità quando il gioco d’azzardo, terribilmente adulto, lascia il posto al teatro di risa che servirà a intrattenere il piccolo Masao, ormai consapevole dell’abbandono della madre.
E qui si evidenzia il primo grande topos kitaneo, prettamente “filmico”, ma su cui il nostro agisce con grande innovazione: il ritorno allo yakuza movie.
Proprio gli anni ‘90, infatti, videro un proliferare di commedie romantiche in Giappone, fenomeno che accantonò quasi del tutto il genere del gangster movie, che Kitano riportò in auge prima con Violent Cop e successivamente con Boiling point. Entrambi i film citati fanno però perno sulla violenza tout court, che reprime l’intero tessuto narrativo e accenna solo in parte alle incursioni comiche che si faranno via via sempre più predominanti nei film successivi.
Nella triade filmica in analisi non c’è romanticismo alla Coppola, né l’ascesa/discesa al potere di De Palma, ma la dissacrazione della malavita attraverso l’espediente della comicità, del ridicolo come espressione di uno strato sociale da stigmatizzare, eppure sempre avvinto da una possente carica tragica. La yakuza è un medium narrativo, e porta una sorte in sé distruttiva, che si immagina però rappresentazione della realtà e dei sogni dell’uomo, dell’infrangersi degli stessi contro le sbarre della vita vista come concatenazione di eventi ineludibili, e che montano in arte l’anti-divino, l’uccisione del libero arbitrio, il gioco come insieme di regole che non può essere sconfitto. Parafrasando Kentaro Miura, autore del manga Berserk, si può cambiare il corso della storia solo uscendone, e dalla realtà si esce solo attraverso la morte, rendendo impossibile ogni arbitrio compiuto.
Già in Boiling point, lo yakuza interpretato da Kitano assume le fattezze di una folle maschera tragicomica, impegnata e frustrata nel tentativo di giocare a frisbee con la compagna e il suo socio, poco prima di abusare sessualmente di entrambi. Quel momento di condivisione, di primo acchito uno spunto di evasione fanciullesca dallo sfondo tragico della vicenda principale, ci riporta brutalmente alla realtà degli abusi e di una vita, quella del protagonista interpretato da Kitano stesso, ormai priva di scelta, cosciente dell’impossibilità della fuga. Proprio da Boiling Point comincia un evoluzione concettuale e narrativa: qui la fuga è momento passeggero, quasi un pensiero fugato immediatamente dalla realtà, la battaglia tragica dei giovani protagonisti perdura attraverso tutto il film, rimarcando in ogni modo l’impossibilità di tornare indietro nella vita, di poter solo e soltanto andare avanti. La panacea, in quest’opera, può trovarsi unicamente nell’ambiguo finale, dove il time lapse ci riporta all’inizio, quando “tutto è ancora possibile”. Non siamo ancora, quindi, nelle lande dei tre capolavori di cui parliamo, che pur accettando momenti al di là del reale, non lasciano mai intendere che il dolore e la sofferenza possano essere evitati o cancellati tornando indietro nel tempo. Non si può uscire dalla fiaba se non con la morte, non si può guarire se non congelando il tempo nella fiaba, e fare in modo che, anche se per poco, la fiaba e la realtà coincidano.
Il gioco come salvezza
Il secondo e più importante topos narrativo (e anche sostanziale) nella triade filmica di Beat Takeshi è proprio il gioco: panacea dei mali, carezza dell’inevitabile, esorcismo del male di vivere, che in tutte e tre le opere, dopo un primo atto privo d’ironia, si insinua nella pellicola.
In Sonatine veniamo immersi in uno strato suburbano di bande mafiose, permeato dalla tensione tra i diversi componenti della stessa banda protagonista, è in atto una lotta intestina per il raggiungimento di un pezzetto di potere sempre più ampio, una prevaricazione incalzante, che ha già portato il protagonista, interpretato dallo stesso Kitano in tutti e tre i film, a volersene distaccare, deciso a voler ‘uscire dal giro’. Ma prima di poter prendere una decisione viene coinvolto in un’ultima missione.
Hana Bi ci immerge nella tragedia già dalle premesse in conosciamo il doloroso presente-passato del poliziotto protagonista e la scintilla di ciò che innescherà il suo viaggio con la moglie: il grave ferimento del suo partner lavorativo e l’uccisione di un altro collega. I due tragici eventi si collegheranno alle colpe personali di Kitano, già ferito dalla morte precoce della figlioletta e dalla malattia terminale della moglie.
L’estate di Kikujiro inizia in modo non dissimile gettando le basi del futuro del piccolo Masao, che è costretto, durante le vacanze estive, alla solitudine della dimora condivisa con sua nonna. Da lì l’impulso di andare in cerca della madre, dopo aver trovato il suo nuovo indirizzo e una vecchia foto nascosti in un cassetto.
Sonatine bruscamente, Hana bi sottilmente, introducono nel secondo atto il gioco, la fuga, mentre Kikujiro, come vedremo, lo introduce veramente solo nel terzo atto, compensando il ritardo con la predominanza del tema rispetto agli altri due nell’economia generale dell’opera, e con un secondo atto che è una vera e propria successione di gag.
Sonatine parte dalla fuga “fisica” dagli yakuza rivali, e il rifugio sulla spiaggia muta in landa di sogno, prigione e alcova, teatro di ricordi; in Hana Bi il nostro porta con sé la moglie in un viaggio silente, costellato di gag comiche intervallate da giochi con le carte, aquiloni nel cielo, fuochi d’artificio (i fiori di fuoco del titolo italiano) abbracci scostanti, l’ironia come arma e come scudo.
Sulla spiaggia di Sonatine, i terribili yakuza regrediscono a un mondo privo di responsabilità, attendono di conoscere la loro sorte, passivi; il frisbee, che in Boiling Point era solo il preludio ad un’esplosione improvvisa di violenza, torna in Sonatine insieme alla lenta contemplazione del sumo, le buche seminate tra le sabbie, la doccia sotto il cielo in diluvio che li disegna come bambini senza alcuna preoccupazione per il futuro; in Hana Bi il protagonista è ben cosciente, a differenza di Sonatine, che nulla può farlo tornare indietro, che l’irreparabile è condizione fondante dell’esistenza, e il tempo un luogo in se stesso, fintanto che la realtà non arriva a svegliarlo, dissipandone i confini spaziali. Il viaggio di Hana Bi è fin dal principio un “ultimo viaggio” ed è come tale liberatorio, un fiume di violenza che travolge ogni ostacolo, una sequenza di scelte messe in scena da un uomo perfettamente libero, ormai rassegnato eppure terribile, incosciente ma generoso con chi gli è più caro. Non c’è sogno né illusione, solo un uomo che non può far altro che alleviare il decorso del suo mondo alla maniera del suo demiurgo Kitano: il gioco come azione ed avversario del pensiero.
Il personaggio di Hana Bi è diverso da quello visto di Sonatine: come lo stesso Kitano ricorda in un’intervista, la sonatina (letteralmente una piccola sonata musicale) definisce l’opera: affrontare o sfuggire la paura, scegliere tra il rifugio sicuro dell’infanzia o il tenebroso universo della vita adulta, scelta preceduta dalla bellissima e terribile scena della roulette russa sulla spiaggia. In questa scena, quando Kitano impugna la pistola (in odore di posticcio, quasi a rendersi anch’essa strumento ambivalente tra il potere dell’immaginazione infantile e la violenza insopprimibile dello yakuza) infanzia e vita adulta si confondono. Il gioco terribile diventa il modo in cui il nostro si dichiara alla paura, si concede alle passioni e alle tentazioni di una vita felice e ne viene poi strappato via: poiché la violenza è l’anticamera e la sostanza della vita. Allo stesso tempo è anche una rivelazione: non si può cambiare, non si può fuggire; paura della morte, desiderio della morte.
La spiaggia felice non è altro che la summa dei rimpianti della giovinezza, di un tempo che non può tornare. È questo che spinge il protagonista verso la sua fine tragica, con l’apparente finestra di un possibile amore e un futuro insperato, una luce che capisce ben presto di non poter abbracciare. Come è tragica la fine in Hana Bi, ma il teatro di giochi improvvisato da Kitano per sua moglie è anche l’ultimo regalo, un susseguirsi di azioni per evitare i pensieri, di risate per scacciare via le inevitabili lacrime, una resa dei conti imposta dagli eventi, e il regalo per la compagna come principale obiettivo.
In Hana Bi il gioco, come anche in Kikujiro, diventa strumento di salvazione, mitiga l’inevitabile decorso della tragedia della vita, ne precorre e percorre i sentieri più oscuri: più che fuga è tenero asservimento, dolce discesa in un abisso previsto, palliativo elevato a necessità; con un’unica implicazione che è dogma in questa parentesi filmica: la vita come tragedia. La disperazione di una vita al limite ci conduce all’ultimo viaggio di una coppia gravata dalla tragedia di una figlia perduta; la delicatezza nel silenzio dei loro sguardi e le piccole gioie degli scherzi infantili, l’ilarità del gioco, la scusa per un sorriso forzato e un ringraziamento finale prima dell’uscita di scena sul campo largo di un mare sconfinato. Questo è il più grande capolavoro di Kitano, il perfetto bilanciamento tra la grave hybris dell’antieroe, labili ma efficaci incursioni comiche, e l’umanità che emerge e si concreta alla fine del viaggio.
In Kikujiro i giochi sono frutto dello sforzo di un gruppo assortito e improbabile di adulti falliti, che tentano di distrarre il piccolo Masao dalla dolorosa verità che conosciamo appena prima della fine del secondo atto: sua madre lo ha abbandonato, formando una nuova famiglia. Se i primi due atti sono pieni di gag e scene di dolorosa ilarità, il terzo atto mette proprio il gioco al centro della vicenda, la fantasia di quattro anime unite dall’obiettivo comune di distrarre un bambino dal suo tormento, riconducendolo a casa con un animo diverso: il sorriso del bambino veste le ali che spuntano dal suo nuovo zaino azzurro.
Così gli adulti si improvvisano pesci in un lago in cui è impossibile pescare, solo per la soddisfazione del piccolo Masao, improvvisano un campeggio, si dondolano con la fune, riscoprono l’un due tre stella, si travestono da alieni. Il bambino rincontra, ogni volta che si addormenta, i personaggi che hanno costellato la sua estate, le brutture di quel viaggio, sognandoli come fossero in un surreale teatro giapponese; nel terzo atto le visioni si fanno gioiose, i traumi mutano in speranze, e tutto grazie a quattro disperati incontrati per caso, che danno forma ai suoi ricordi, sostanza al suo futuro.
Come Sonatine, anche in Kikujiro è alta la voce del rimpianto: gli occhi del personaggio di Kitano incontrano quelli di Masao, li riconosce, vede un giovane se stesso, sa a cos’è destinato, e possiamo anche immaginare, con uno sforzo interpretativo, che il piccolo Masao altro non sia che il veicolo dei ricordi di Kitano stesso. Se accettassimo questa visione, il finale assumerebbe contorni più oscuri e drammatici, più consoni ai toni di Sonatine e Hana Bi. O forse Kikujiro è solo un grande viaggio, che rende il bambino realmente bambino e l’adulto finalmente adulto.
Gioco e violenza, sogno e speranza
Dai tre lungometraggi ciò che emerge chiaramente è il rilievo che Kitano dà sia all’infanzia perduta che al gioco come strumento curativo. Il gioco è infatti strumento per adulti, non per bambini. Anche in Kikujiro, Masao e il personaggio di Kitano si confondono, come se il bambino non fosse altro che un ricordo tratto in salvo da un se stesso immaginario.
Sicuramente il retaggio artistico ed esistenziale di Beat Takeshi influenza le sue opere filmiche in modo predominante (va ricordato che Violent Cop iniziò con un regista diverso, che abbandonò in corso d’opera lasciando a lui le redini del film; mentre Boiling Point può essere considerato il suo vero esordio, ancorato a una violenza ancora primordiale) ed è proprio l’accoglienza a lui riservata in patria a lasciarci l’amarezza nel constatare che in Giappone la figura di Kitano sia da sempre saldamente legata a Takeshi’s Castle e al mondo dello stand up e delle trasmissioni comiche, mentre in Europa è da sempre considerato un cineasta di primissimo livello. Eppure proprio questa sua prerogativa comica, e quindi l’esperienza di Takeshi’s Castle in primis, insieme alla resurrezione dello yakuza movie, ci permettono di godere dei suoi capolavori, frutto delle molteplici sfaccettature artistiche di Kitano (per esempio in Hana Bi, tutti i dipinti in cui si cimenta il poliziotto invalido sono opere autentiche del regista). La depressione di Takeshi dopo l’incidente stradale influisce inevitabilmente sulle sue opere, calate in un contesto solo apparentemente fatalista, ma in realtà magico e inesorabile, sanguigno e gioioso. Vite accompagnate dalle magnifiche musiche di Joe Hisaishi, sodale di Kitano, che affresca opere sontuose e commoventi, capaci di immergere come di affogare.
Nei tre lungometraggi del periodo 1993-1996 l’infanzia perduta è il luogo del rifugio, della pace, la spensieratezza dell’irresponsabilità, e in ognuna delle tre opere i protagonisti vi approcciano come metodo di salvezza ma con una consapevolezza ogni volta diversa: ora trattando il gioco come terapia del dolore, ora come illusione di una cura, di evasione da una realtà irreparabile. Ma non si può rimanere bambini troppo a lungo: la realtà irrompe, nonostante tutto, e il gioco è l’unico sollievo da un promemoria obbligato e tragico.
In Sonatine l’illusione è padrona assoluta, e la scelta non è un momento consapevole del protagonista, ma indotto dall’irruzione della realtà in quel teatro di giochi improvvisato sulla spiaggia – realtà impersonata dal killer mandato dagli yakuza – e che impone a Kitano una scelta forzata, indirizzandolo verso una violenza senza ritorno.
Come la scena della roulette russa investe il secondo atto di Sonatine di una violenza ‘infantile’, irrompe cioè mescolandosi alla spensieratezza del gioco, Hana Bi lo utilizza senza commistioni iconografiche, intervallando al viaggio della coppia – con le sue gag, i giochi di carte, i rintocchi vietati di una campana buddista – la terribile violenza del nostro, disposto a tutto pur di riparare ai suoi errori e lasciar vivere a sua moglie gli ultimi attimi felici.
E allora avventuriamoci in un’altra interpretazione, quella dell’aquilone nella scena finale di Hana Bi: forse entrambi partecipano a una visione in cui la figlia gioca sulla spiaggia, o invece immaginano come sarebbe stato, guardando una ragazza reale, avere ancora la figlia con sé? Immaginare questo dramma a spirale che conduce ad altri eventi è una filosofia della catastrofe, così la camera si sposta sul mare aperto, la pistola esplode i suoi colpi. Sipario.
In Sonatine, la scelta è sempre la vendetta, dopo la quale non rimane nulla allo yakuza Kitano. L’amore possibile pochi metri più in là, sulla strada, come i giochi fatti sulla spiaggia avvinti alla dimensione dell’illusione. Una volta che si affronta la battaglia, si smette di fuggire. Fuori dalla fuga, solo la morte. Sipario.
Ecco il gioco, tomba della morte, elogio alla vita.