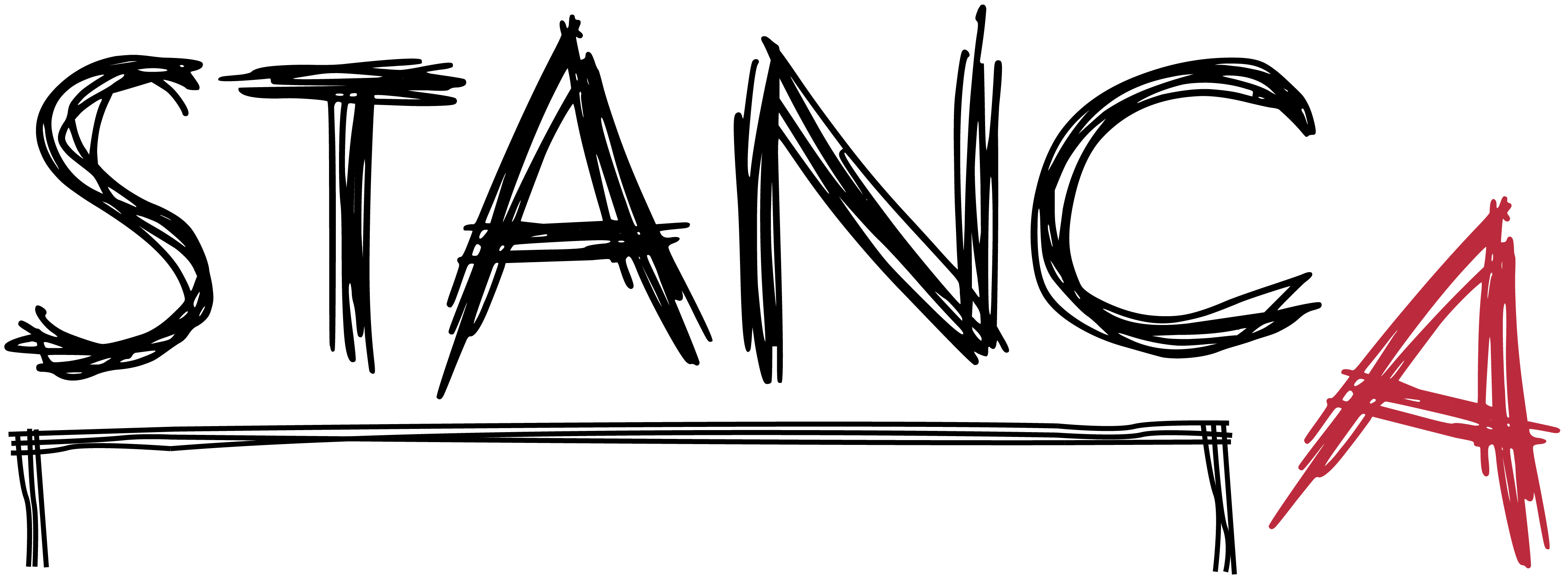Thèo e Isabelle, due gemelli cinefili, vivono nel loro mondo, costruito su una misura ben precisa: il perimetro della loro casa in centro a Parigi. Le pareti dell’appartamento diventano superfici su cui proiettare immagini di film: quei film che i due gemelli hanno respirato, interiorizzato, digerito e imparato a memoria come versetti della Bibbia. La casa signorile di The Dreamers diventa un luogo “altro”, fatto di storie immaginarie. Un luogo seducente che fagocita i protagonisti, strappandoli alle complessità dell’esterno. Dall’iniziale attivismo politico per le strade della città francese, Thèo e Isabelle, insieme all’amico americano Matthew, cominciano a sprofondare nel tepore artificiale della casa dei genitori, spariti in un lungo viaggio. Loro sembrano non accorgersene, e per un po’ quasi non ce ne accorgiamo anche noi: come Thèo, Isabelle e Matthew, veniamo fagocitati dalle viscere soffocanti e materne della casa e dalla spirale docile e autodistruttiva che innesca. L’edificio in cui si svolge gran parte dell’azione di The Dreamers è connotato in senso politico in più modi, a partire dall’architettura stessa del luogo, che tradisce la posizione sociale elevata dei fratelli e della loro famiglia. Ma la sua connotazione politica si articola anche e soprattutto nel suo rapporto con l’esterno. L’appartamento di The Dreamers è un rifugio, un ventre materno che si tenta di rifiutare ma in cui si finisce sempre invischiati: Thèo, Isabelle e Matthew ne abitano le stanze e i corridoi in maniera ossessiva, affermando costantemente la presenza dei loro corpi sulla scena. Hanno tutto quello di cui hanno bisogno: perché andare a cercarsi altre rogne fuori quando si può stare dentro casa a parlare di Charlie Chaplin e Buster Keaton e fare il bagno nudi tutti insieme?
È una prospettiva affascinante e un equilibrio che tutto sommato funziona, almeno fino a un certo punto, finché il rapporto amoroso tra Isabelle e Matthew non rischia di incrinare lo stato immutabile delle cose: quel legame di sangue e di vita con Thèo che per sua stessa natura è escludente, non può tollerare l’ingerenza di terze persone. Può allargarsi temporaneamente, può ospitare delle interferenze: ma non può durare per sempre, come fa notare in modo esplicito lo stesso Thèo. E infatti non dura per sempre: quell’idillio familiare che sostituisce la famiglia è destinato a spezzarsi, travolto dalle forze inarrestabili del mondo esterno, che non conoscono né mura né finestre, e di certo non si premurano di bussare alla porta prima di entrare. Anche la felice reclusione dentro casa mostrava le sue incrinature: le discussioni tra Thèo e Matthew sulla guerra in Vietnam erano già le prime crepe di un piccolo mondo destinato a implodere, le prime incursioni della realtà dentro la bolla rarefatta messa in piedi dai tre amici.
Poi il mondo entra nella casa, nel rifugio fatto di sogni e di passioni, in tutta la sua matericità: una finestra che va in frantumi, cocci di vetro dappertutto. È il maggio francese che chiede con forza una presa di posizione, infrange le sicurezze e le illusioni di poter trovare facili rifugi lontani dal caos della contemporaneità. Il momento della lotta è adesso: è il momento di prendere una decisione. E su quella finestra in frantumi e nella conseguente discesa in strada si giocano le sorti di tutto il film: il finale di The Dreamers diventa un piccolo compendio sulla lotta politica, su cosa significa schierarsi e agire, su qual è il ruolo della violenza in questo paradigma. «Books, not guns, culture, not violence» è una delle scene più citate del film di Bertolucci: sono le postulazioni elaborate da Thèo, Isabelle e Matthew quando sono ancora cullati dalle dolci e assuefanti braccia della casa genitoriale. Ma la rivolta del ’68 messa in scena negli ultimi minuti di The Dreamers mette tutto in discussione, compresi questi facili e fragili assiomi. Se in The Dreamers la casa è un rifugio che, seppur attraversato da forze perturbanti e morbose, si configura come un tentativo di ripararsi dall’esterno, in altre opere la casa diventa il centro nevralgico del conflitto, di una lotta che non si riversa solo nelle strade ma pervade le fondamenta delle esistenze stesse, le dimore di famiglia e il valore identitario che recano con sé.

È il caso di The Last Black Man in San Francisco, nel quale si parla della questione abitativa e della discriminazione razziale nel settore immobiliare. Film uscito nel 2019 e diretto da Joe Talbot al suo esordio alla regia, racconta le vicende autobiografiche dell’attore Jimmie Fails, la cui casa di famiglia era stata pignorata quando era bambino. Il film racconta di un giovane afroamericano che decide di trasferirsi insieme a un suo amico nella casa costruita da suo nonno.
The Last Black Man in San Francisco è una storia di solitudine, emarginazione, resistenza e comunità. Ma è anche una storia di traumi, di genealogie spezzate e inventate, di tentativi di ricostruire il contatto con la terra, con la città e di rivendicazione dell’eredità creativa dei propri antenati, quella stessa eredità che la supremazia bianca ha cercato in ogni modo di cancellare dalla geografia e dalla memoria. Jimmie Fails ricorda che: «Lo sfratto è stato un evento che mi ha cambiato la vita, ed è come se non avessi più una famiglia da allora. È come se fossimo tutti divisi e ognuno avesse preso la sua strada». Una storia simile è raccontata da bell hooks nel suo Sentirsi a casa: Una cultura dei luoghi, nel quale la teorica americana traccia le coordinate del suo desiderio di appartenenza, della necessità di avere un luogo da riconoscere come casa, con tutti i suoi paesaggi segnati dal trauma, dall’oppressione e dalla segregazione, ma anche dai valori e dalle pratiche contro egemoniche. Un universo dominato da un potere razzista, che contiene dentro di sé sacche di resistenza che traggono la loro forza dal contatto con la terra, dalla conservazione di una cultura di appartenenza che riesce a lasciare il segno sul paesaggio dilaniato dai confini tracciati con violenza dalla cultura dominante: «un mondo plasmato dalle forze feudali del capitalismo suprematista e imperialista bianco, ma anche tutti i modi fantasiosi escogitati dai neri per sopravvivere e prosperare, nonostante lo sfruttamento e l’oppressione».
L’autrice in Sentirsi a casa parte dalla sua scelta di ritornare nelle colline del Kentucky, la sua terra di origine; parla della storia dimenticata di quella regione, dei contadini e proprietari terrieri neri, delle migrazioni verso il Nord industrializzato, del senso di sradicamento che danneggia la psiche e genera traumi che si tramandano di generazioni in generazione. Anche The Last Black Man in San Francisco si basa su queste ferite che travalicano i confini di una singola esistenza per trasformarsi in traumi collettivi. Al centro del film di Talbot troviamo un ritorno, che non solo innesca l’azione, ma diventa uno strumento in grado di scandagliare il passato, rendendolo materia viva, in un rapporto di scambio col presente. La città stessa è in costante cambiamento: in questo vortice di trasformazioni, Jimmie spera di recuperare ciò che è stato costruito in passato dalla sua famiglia e di poter agire a sua volta sulle tracce lasciate dai suoi antenati. Così quando il nonno muore, la casa rimane vuota e Jimmie vi si stabilisce, la arreda, se ne prende cura.
La questione centrale è il diritto abitativo, che diventa una chiave di lettura attraverso cui leggere i cambiamenti che attraversano e stravolgono il tessuto urbano. Chi merita di vivere in città? È possibile creare spazi di resistenza in uno spazio urbano sempre più gentrificato e spersonalizzato? «Indipendentemente dalla posizione politica, di destra o di sinistra, in merito alla proprietà immobiliare la maggior parte delle persone è conservatrice, e non è disposta a mettere in pratica l’antirazzismo» è la considerazione netta di bell hooks in Sentirsi a casa. «A dispetto di tutti i luoghi che sono diventati formalmente integrati, come i posti di lavori, i negozi, i club, i ristoranti ecc – in cui leggi necessarie hanno reso difficile la messa in atto di comportamenti discriminatori – il settore abitativo rimane uno di quelli in cui è praticamente impossibile “dimostrare” il verificarsi della discriminazione, ed è quello nel quale la politica della supremazia bianca, dell’esclusione razziale e della segregazione è tuttora la norma. Ciò è particolarmente vero nei luoghi in cui le comunità esclusive, le associazioni di condomini e le cooperative hanno il diritto di intervistare i candidati e rifiutarli per i diritti più svariati».
Il territorio della casa non può essere concepito solo come un luogo privato, ma come un campo di estensione delle dinamiche di potere che pervadono la città, un posto dove le forme di discriminazione si replicano in modo più sottile ma non per questo meno pervasivo e violento rispetto alle già violenze istituzionalizzate degli anni della segregazione. Le logiche che regolano l’appartenenza e il diritto abitativo non seguono un sentimento comunitario volto alla coesione e alla convivenza, ma perseguono la disgregazione, la frammentarietà e la creazione di solitudini deboli e prive di identità e di passato. «Alla base di molti nuovi insediamenti abitativi, in particolare quelli il cui perimetro è delimitato da una recinzione di confine, c’è un principio di esclusione ed esclusività finalizzato a tenere gli elementi indesiderati fuori dal perimetro, ovvero le persone della classe, o del colore, sbagliati», prosegue hooks nella sua disamina degli insediamenti abitativi delle città statunitensi e della zonizzazione economica e razziale degli alloggi.

Esclusione ed esclusività sono le parole chiavi, due parole determinate da un terreno culturale in cui la discriminazione razziale e di classe si intersecano e si fortificano a vicenda: tracciare confini, creare gerarchie, decidere chi sta dentro e chi sta fuori, distribuire e confiscare diritti fondamentali. La dimensione politica dell’abitazione viene rappresentata in maniera feroce in Bush Mama, diretto dal regista etiope Haile Gerima. Il film mostra la condizione di Dorothy, una donna nera incinta che vive nel quartiere di Watts a Los Angeles in stato di povertà e cerca di crescere sua figlia mentre il marito è in carcere per un crimine che non ha commesso. Le immagini che formano il tessuto filmico di Bush Mama sono violente, implacabili, esplosive: Gerima mette in scena le molteplici violenze istituzionali che stravolgono la vita di Dorothy e della figlia Luann. La città è aggressiva e incurante di ogni valore e di ogni forma di vita che non corrisponda ai suoi canoni: un perfetto prodotto del sistema capitalista, suprematista e imperialista bianco già descritto da hooks, dove non c’è spazio per il nutrimento dell’anima e per la costruzione di comunità amorevoli.
Se in The Last Black Man In San Francisco assistiamo alla rivoluzione morbida (termine usato da hooks) messa in atto da Jimmie, attraverso il suo potente atto trasformativo di attingere dal passato per immaginare all’interno della casa un nuovo spazio di comunità e di resistenza, in Bush Mama la casa diventa vero e proprio luogo di conflitto e di rivolta. Dopo aver subito l’ennesima e intollerabile violenza, Dorothy elimina il simbolo della violenza istituzionalizzata che ha plasmato la sua esistenza: prende un bastone e uccide il poliziotto che sta abusando della figlia. Tra i detriti di una civiltà egemonica al collasso non c’è solo disperazione e dolore, ma anche una radicale presa di coscienza politica. Il film si conclude con una scena in cui Dorothy scrive al marito dal carcere, parlando della propria presa di consapevolezza: Gerima ce la mostra con i suoi capelli naturali, finora nascosti sotto una parrucca.
Come scrivono Ricci e Veronesi in Dorothy non abita più qui:“La casa riassume tutti i luoghi emblematici: è lo spazio della segregazione, ma è anche lo scenario in cui avvengono la violenza e la rivolta, è il territorio in cui matura la coscienza e in cui si mette in atto la scoperta del sé e delle radici. La casa è insomma il luogo da cui si proviene, da cui si è stati estirpati e a cui si deve fare ritorno”. Il corpo di Dorothy e lo spazio che abita sono luoghi dominati dal potere patriarcale suprematista bianco, in un incrocio di razzismo e sessismo, ma in quanto tali necessariamente diventano gli unici luoghi possibili di resistenza e ribellione. Così la figura di Dorothy e lo spazio domestico in cui si muove acquisisce una valenza nuova.
La dimensione del focolare domestico acquisisce una dimensione politica radicale, valore sovversivo nella lotta contro il sistema patriarcale e razzista, ruolo centrale delle donne nere nella sua costruzione, descritto da hooks in un altro saggio dedicato alla casa, Casa: Un luogo di resistenza, contenuto nella raccolta Elogio del margine: «Anche nella realtà dell’apartheid razziale, della dominazione, la casa era l’unico sito dove potersi misurare in modo libero con la propria umanità, dove poter resistere, Le donne nere hanno resistito erigendo case dove tutti i neri potessero lottare per essere soggetti, non oggetti, dove potessimo confermarci nella mente e nel cuore, nonostante la povertà, la fatica, le privazioni, dove potessimo restituire a noi stessi la dignità che all’esterno, nella sfera pubblica, ci veniva negata. […] Anche se le donne nere non hanno articolato razionalmente in un discorso scritto i principi teorici della decolonizzazione, non per questo le loro azioni sono meno importanti. Intellettualmente e intuitivamente esse capivano qual era il significato del focolare domestico all’interno di una realtà sociale oppressiva e violenta, il senso del focolare domestico come luogo di resistenza e di lotta per la libertà.»

La casa come spazio di costruzione e distruzione: dalla dimora in decadenza e colma di nevrosi di The Dreamers, dove gli ideali prendono corpo solo nel momento in cui la strada invade lo spazio domestico, al progetto utopico di Jimmie che cerca di ridisegnare la fisionomia di una città in piena gentrificazione, attraverso la rivendicazione del suo spazio abitativo, fino alla rivolta incendiaria che divampa nella casa di Bush Mama, dove Dorothy acquisisce la sua consapevolezza politica. Il filo che unisce queste tre storie è il processo ciclico di distruzione e costruzione in cui la casa diventa luogo simbolo di oppressioni e di resistenze, in cui i confini tra privato e pubblico diventano sempre più sfumati, e dove i muri diventano limiti valicabili e custodi di memoria che delimitano uno spazio dove «tornare a rinnovarci e a curare noi stessi, dove guarire dalle nostre ferite e diventare interi» (bell hooks, Elogio dal margine).